[Quella che segue è una sintesi dell’introduzione con cui lo scorso lunedì ho aperto il Gruppo di discussione filosofica che si tiene mensilmente presso la Biblioteca di Rescaldina. Ho cercato di mantenere, per quanto mi è stato possibile nel passaggio alla stesura scritta, il tono colloquiale e il carattere divulgativo. Il tema in discussione era: (Iper)consumi: necessità, bisogni, desideri]
Partiamo dal titolo del nostro incontro: già il prefisso “iper” comporta un giudizio di valore (che è però tutto da argomentare). A tal proposito appare ovvio come ogni società umana (e dunque ogni singolo umano) non possa non consumare per sopravvivere. Senonché – anche questa è un’ovvietà – si sono date storicamente forme sociali diverse con modi diversi di consumare, uno dei quali è l’attuale, il tardo sistema capitalistico globale. Un sistema che non è eterno e che potrà in futuro essere modificato o sostituito. Questo modello viene da più parti denominato e caratterizzato come “consumistico” – ad indicare genericamente un eccesso di consumi, o un’eccessiva concentrazione sulla logica del consumo (senza magari farsi domande su motivazioni, radici, cause, effetti, ecc.). È comunque evidente che non ci sono mai state società in passato che abbiano consumato così tanto, così diffusamente ed intensivamente.
Ma la mia attenzione si volgerà piuttosto all’altra parte del titolo: necessità – bisogni – desideri, e verterà sul lato “soggettivo” più che oggettivo. Ci chiederemo cioè quali sono le spinte interne all’individuo che determinano la logica del consumo. E per far ciò partiremo dall’analisi di un celebre filosofo olandese del ‘600, autore di una interessante teoria della natura umana, ed in particolare delle “passioni” umane: Baruch Spinoza (1632-1677).
Egli parte da una constatazione di tipo generale (se vogliamo universale): ogni essere tende a conservarsi e a perseverare nel proprio essere. Per “essere” intendiamo ogni cosa, individuo, vivente, ecc.: sia esso una pietra, un animale o un essere umano – tutti questi “enti” possiedono un vero e proprio istinto naturale di conservazione, una tensione interna (conatus è il termine latino utilizzato da Spinoza, che può essere tradotto con sforzo) che li fa essere quel che sono. E li fa essere così indefinitamente: dipendesse solo da loro, essi esisterebbero per sempre, sarebbero immortali. Senonché il loro essere viene interrotto da fattori esterni (urti, incidenti, malattie, morte, decomposizione, ecc.).
Nel caso dei viventi questo istinto conservativo si manifesta in una forma ancora più evidente, attraverso un vero e proprio impulso ad autoaffermarsi, ad espandersi, a “perfezionarsi” sempre di più. Spinoza introduce a questo punto il concetto di “affetto” (affectus, da intendersi come affezione, essere affetti da qualcosa – più in generale potremmo anche tradurlo “passione”), e identifica tre affetti primari che contraddistinguono il funzionamento naturale di ogni individuo:
letizia – tristezza – desiderio.
È questa la triade fondamentale che costituisce la base del complesso meccanismo delle passioni. Che è però riducibile a due movimenti essenziali: si ha letizia (piacere, felicità) quando l’essere o l’individuo aumenta il proprio grado di perfezione; si prova al contrario tristezza (dolore, infelicità) quando l’essere diminuisce il proprio grado di perfezione. In questa pendolarità tra uno stato negativo ed uno positivo, svolge un compito fondamentale il desiderio (appetitus, od anche cupiditas), cioè la nostra naturale tendenza ad appropriarci del mondo esterno – cibo, oggetti, altri esseri o viventi, individui, stati mentali, ecc. Ed è in primo luogo il corpo a desiderare (laddove l’equivalente mentale parallelo è la volontà). Spinoza rovescia qui tra l’altro il tradizionale punto di vista sui concetti di bene e male: «noi non tendiamo a una cosa – scrive nell’Etica – non la vogliamo, appetiamo o desideriamo perché giudichiamo che sia buona, ma, al contrario, giudichiamo che sia buona perché ci sforziamo di ottenerla, perché la vogliamo, l’appetiamo e la desideriamo».
Utilizziamo solo questo frammento della teoria spinozista, non occupandoci per ora dei problemi etici o dell’intervento della ragione nella gestione delle passioni: ci basti per ora sapere che le leggi che regolano le passioni non sono in nostro potere, ma sono naturalmente determinate.
Sorgono però subito due ordini di problemi (e qui entreremo nel merito degli scritti che vi avevo segnalato la volta scorsa, come base utile alla nostra discussione): 1) questo meccanismo espansivo e desiderante appare a ben vedere come smisurato, senza alcun limite, e dunque potrebbe potenzialmente diventare autodistruttivo; 2) non solo: si scontra anche con tutte le altre individualità (non solo umane) che hanno – in quanto esseri viventi – un eguale diritto naturale ad autoaffermarsi e ad esercitare quella che Spinoza definisce “potenza” – sviluppo delle proprie facoltà.
La concezione platonica del desiderio (richiamata nella pagina di Umberto Galimberti sul consumo delle droghe, tratta dal suo saggio L’ospite inquietante) ha proprio a che fare con il primo dei nostri problemi, quello del carattere smisurato ed illimitato del desiderio. Platone utilizza nel Gorgia tre interessanti metafore per descrivere questo stato di insaziabilità: l’anima umana è come l’orcio forato nel quale viene continuamente versata dell’acqua; o come quell’uccello – il caradrio o piviere – che mentre mangia evacua; se non addirittura come la scabbia: qui Socrate cerca di far entrare in contraddizione il suo interlocutore, Callicle, il quale ha sposato la causa illimitata del desiderio come fonte inesauribile di gioia, obiettando come non possa essere felice la condizione di qualcuno che, avendo la scabbia, passa tutta la sua vita a grattarsi. Inguaribilità, dunque, del desiderio, come se si trattasse di una malattia; insaturabilità (termine utilizzato da Galimberti); permanente infelicità del drogato-dipendente-onnidesiderante, il quale manca sempre di qualcosa.
(É proprio questo tipo di dipendenza che viene contestato dai cinici, e da Diogene in particolare: l’autarkéia, l’autodeterminazione, comporta una totale libertà da ogni forma di schiavitù e di assoggettamento, in primis dai desideri e dalle passioni, da ciò che ci farebbe vivere in uno stato falso ed esteriore, lontano dall’essenzialità naturale).
Ma veniamo ora alla concezione epicurea. Con l’analisi di Epicuro si comprende meglio il senso della progressione
necessità – bisogni – desideri.
Egli qualifica come “desideri” tutte le spinte pulsionali umane che si rivolgono al mondo esterno, ma indica anche una vera e propria gerarchia valoriale: esistono desideri primari (necessari e naturali – ciò senza di cui non potremmo vivere), secondari (naturali ma non necessari), ed infine desideri che si allontanano del tutto dai nostri bisogni essenziali. Epicuro li definisce come vani prodotti dell’opinione (doxa). La progressione sembra andare dal determinato all’indeterminato, dal corporeo all’incorporeo, dal materiale all’immaginario, ma soprattutto dall’essenziale all’inessenziale. Mentre sono chiari, oggettivi e determinati i nostri bisogni primari, man mano che la sfera del desiderio si allontana dalle necessità immediate, si fa sfumata, ma soprattutto illimitata, indefinita, smisurata. Epicuro non ha dubbi: allontanarci dalla necessità naturale comporta sempre il rischio di cadere in uno stato perenne di insoddisfazione, e dunque di dolore. Solo la limitazione del desiderio garantisce una vita piacevole – laddove il piacere è innanzitutto l’assenza di dolore.
Romano Madera riprende, senza però citarli, tanto la concezione di Epicuro quanto quella di Platone, attualizzandole ed applicandone gli schemi teorici alla società capitalistica avanzata: il termine licitazionismo (mutuato dal verso dantesco “libito fe’ licito in sua legge“, là dove nel canto V dell’Inferno si parla della regina Semiramide), indica la deificazione del desiderio, la sua istituzione in qualità di unica ed ultima legge universale. Tutto ciò comporta la totale espulsione della categoria di sacrificio e l’introduzione nella vita sociale e degli individui di massicce dosi di narcisismo, ansie da prestazione, spettacolarizzazione, e insieme la genesi di forme morbose e patologiche, disturbi alimentari, depressioni, maniacalità. ecc.
Marx aveva intravvisto tali pericoli distorsivi, quando nei Manoscritti economico-filosofici aveva cominciato ad analizzare l’immane potenza del denaro, una delle costruzioni più astratte e raffinate che mai siano state concepite dagli umani, i quali finiscono per non avere più come scopo primario quello della produzione di oggetti (che pure devono abbondare ed anzi proliferare), ma del medesimo stato desiderante: il sistema capitalistico per continuare a mantenersi in piedi deve produrre innanzitutto desideri e soggetti (molto più che oggetti) che abbiano in mente una sola cosa: consumare. Un circolo vizioso perfetto.
Il politologo americano Benjamin Barber fa vedere bene come questo processo abbia al centro la logica dell’infantilizzazione. Nel saggio Consumati: da cittadini a clienti (Einaudi, 2010), egli dedica tutta la prima parte all‘analisi dell’ideologia infantilistica che permea questa fase dello sviluppo capitalistico. L’autore sostiene come proprio l’infantilizzazione sia diventata il motore più importante del modello consumistico impostosi negli ultimi decenni, specie dopo l’abbandono dell’originario spirito dell’etica protestante e il passaggio dalla fase della produzione dei beni a quella dei bisogni.
L’operazione in corso è a tenaglia: da una parte abbassare la soglia dell’età del consumo, dall’altra infantilizzare il mondo adulto. Interessante come l’autore rilevi en passant che per far ciò il Capitale utilizza anche la leva dell’indebolimento delle figure parentali, “guardiani del cancello”, al fine di conquistare menti e anime dei bambini, far diventare i bambini dei consumatori e mantenere in un perenne stato infantile e adolescente gli adulti – così da garantire una illimitata logica del gioco del consumo.
Naturalmente tutto questo non tiene conto – o tende a lasciare sullo sfondo, se non far dimenticare e rimuovere in toto – cause ed effetti dell’intero sistema: si vive in un eterno presente del consumo, senza porsi domande sul perché si consuma così e su quali saranno le conseguenze future o ecosistemiche.
Ed è da qui che partiamo per la nostra discussione: che fare? come possiamo contrastare questa tendenza dalla quale i singoli sembrano superagiti, e che dunque pare renderli impotenti (o potenti solo a desiderare indefinitamente)? sarà sufficiente partire da sé e dalle proprie scelte individuali, o magari dagli stili di vita? cosa potranno fare la scuola e l’educazione? il pianeta e l’ecosistema reggeranno ancora a lungo questa nostra ossessiva ed insaziabile cupiditas?
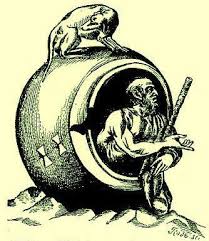


1) fortunati i partecipanti di Rescaldina. Divulgazione (ma divulgazione è dire poco)molto intelligente con l’individuazione di temi sempre interresanti e stimolanti!!! Mario Domina dovrebbe girare per tutte le scuole d’Italia a parlare di filosofia!!! Si dovrebbe trovare nel bilancio pubblico (cosiddetto) un foinanziamento apposta per lui!!! Non sarebbero assolutamente soldi buttati!!!
(basta, ora, con i punti esclamativi)
2) bellisimo l’orcio nella foto. Dove si trova?
al punto 1 non rispondo (e come potrei? troppe laudi…)
mentre il punto 2 è facile, trattasi di piccolo “giallo archeologico”
http://www.antikitera.net/news.asp?id=10777&T=2
Non riesco a considerare il desiderio come qualcosa di negativo tout court.
Siamo degli esseri desideranti, se non desiderassimo saremmo morti o come morti.
Che in fondo, anche il proposito di Diogene di ridurre i desideri al minimo indispensabile, non esisterebbe senza un corrispettivo desiderio (e volontà) di poter esercitare la libertà di ridurre i desideri al minimo. Desiderare di non desiderare, è anch’esso un desiderio. Un desiderio negativo, ma pur sempre desiderio.
Per questo non credo che la via da percorrere sia di avvilire il desiderio, ma piuttosto di scoprire cosa desideriamo davvero, e se quello che desideriamo è la miglior cosa da desiderare.E se stiamo davvero esercitando la nostra volontà e libertà quando cerchiamo di ottenere quello che crediamo essere un nostro desiderio – quando invece magari non lo è, come nel caso dei desideri di bisogni indotti dal mercato.
Ma, in prima istanza sussiste la possibilità di cambiare l’oggetto dei nostri desideri. Ad esempio come quando il desiderio di mangiare carne viene superato dal desiderio di non mangiarla; per cui il desiderio maggiore prevale sul desiderio minore; perché è maggiore il desiderio che mi rende più felice, che mi dà più piacere, che mi appaga di più. Se non fosse maggiore il desiderio di non mangiar carne, se non mi appagasse di più, come potrei perseguirlo?
@rozmilla
giusto è il giusto mezzo. Considerazioni sensate le sue.Ma ciò che crede lei non combacia più con volontà di superamento di ogni limite che sia quello positivo o quello negativo, infatti,ci badi, lei continua a precedere ogni sua frase con la parola “credo”: in un mondo fatto di volontà possiamo solo credere.spunto per approfondire l’argomento il video di Fusaro per Minima Mercatalia.
http://www.filosofico.net/filosss.html
Senta Alessandro, a questo punto del mese ho già consumato da un pezzo la possibilità di connettermi ad alta velocità, ed è per questo non posso vedere video.
Riguardo all’osservazione che faccio precedere le mie frasi con la parola “credo”, certamente uso anch’io come tutti il verbo “credere” con una certa leggerezza e per abitudine linguistica; anche se avrei potuto scrivere in alternativa “penso”, o “ipotizzo”, o “suppongo”, o “sono del parere”, o persino “potrebbe essere” (come potrei sbagliarmi). Quindi, per come la intendo io, non è una affermazione di fede forte né cieca, ma un’ipotesi supportata blandamente dalla mia piccola esperienza, e che ho espresso soltanto per chiedere anche agli altri cosa ne pensavano in proposito.
Però è mio parere che non potessimo esercitare almeno un pochino la nostra volontà, saremmo come paralizzati, morti insomma, non potremmo fare più nulla. Forse non potremmo nemmeno cucinare una minestra.
Un altro esempio che volevo scrivere ieri sera: se non avessi desiderato di andare al gruppo di discussione filosofica alla biblioteca di Rescaldina, me ne sarei stata a casa a fare le solite cose, sul divano o davanti al camino. Magari all’inizio ci sono andata solo per curiosità, ma poi sono stata contenta di esserci stata, e so che desidererò andarci anche la prossima volta. E poi da cosa nasce cosa.
Per me questo significa restare aperti alle possibilità, a ciò che può accadere, e poter scegliere ciò che ritengo migliore: quindi riguarda le scelte che posso esercitare fra varie opzioni. Però so anche che se non ci fosse stata prima ancora la volontà di Md. di organizzare il gruppo di discussione, il gruppo di discussione non ci sarebbe stato, e non avrei potuto scegliere ciò che non c’era.
… in alternativa avrei dovuto organizzarlo io, ma io non ne sarei capace, certo non da sola. E persino Md, se avesse progettato il gruppo di discussione, ma non ci fosse andato nessun altro, non ci sarebbe stato nessun gruppo e nessuna discussione. Per me il bello lo di questa cosa è di poter fare qualcosa insieme agli altri, di confrontarsi con gli altri, e di sentirsi parte di qualcosa.
Poi, si sa, si può sbagliare a parlare, a dire, ma si può migliorare, parlandone … tante cose possono cambiare …
… questa mattina ho trovato in fb una piccola poesia che mi è molto piaciuta.
Sono vicina a credere
al fiore che si apre,
non a grammatiche.
– Nadia Agustoni –
(da Il libro degli haiku bianchi)
@rozmilla
Quello che Md pone e che tu sottolinei è un tema ontologico di straordinaria importanza. Il desiderio (ciò che mi spinge ad agire nell’ambiente) è la molla che, in generale, perpetua l’essere dei viventi (altrimenti la vita si sarebbe estinta da un pezzo). Per la nostra specie la questione di fondo è riassumibile in questa domanda? Avere più del necessario è utile al benessere individuale? Evidentemente no, se il bisogno che mi spinge al possesso delle “cose e delle persone” è di natura puramente psico-sociologica (infantilismo del consumatore coatto, consumatore anche di corpi). Teniamo, poi, presente che la “cupiditas” ci rende inevitabilmente “schiavi” degli “oggetti” desiderati. In tal caso la frattura tra desiderio e libertà diviene insanabile. Paracadutato in un’isola deserta, se non guardo all’essenziale sarò un consumatore morto, per carenza del “superfluo”.
Auto- ridursi, consapevolmente, vincolandosi al fisiologico (alle esigenze della nostra natura basica), ecco la ricetta minimalista del buon vivere.
il desiderio è quella molla… il desiderio è quella parte del tutto che , siccome mi manca mi completa, è la soluzione alla contraddizione della parte nel tutto , tutto qui.
…. a proposito, il mio linguaggio è sempre ontologico e infatti quando dico tutto qui , non riducetelo ad una smorfia di compiacimento e di scanzonamento,.. no , io sono filosofo (ah quanto godo a farvi incazzare), il tutto qui è inteso come tutto adesso , l’origine.
@rozmilla
risolvere tutte le contraddizioni che ha scritto in poche righe mi è impossibile più per il tempo che ho a disposizione che per la volontà (desiderio), ma ad alcune cose pervengo per verità… la fede , tutt’altro che essere qualche cosa di ferreo e diretto sull’oggetto di cui si crede sia vero ha bisogno dell’intermediazione di qualcuno per essere detta vera, non è in definitiva come stanno le cose ma è come qualcuno ci dice che stanno le cose… i suoi credo sono indotti nel suo linguaggio corrente dal fatto che noi viviamo il tempo di volontà e in questo tempo non si può che avere fede, cioè non si può che credere a qualche cosa che non è in luce , ma è riportato alla luce per volontà da qualcuno… alla rilettura del vero significato di fede si rilegaa e capirà dove sta la contraddizione con una mia indicazione … se dice che vive appunto uno stato di possibilità quando dice credo questo stato è in contraddizione con la forza dell’incontrovertibilità che rifiuta uno sguardo riflesso nello specchio di chi crede l’immagine della verità….
questo se qualcuno ha seguito il video di Fusaro che è pertinente all’argomento trattato…
Quello che, in tutto ciò che Fusaro squisitamente dice,vi è escluso è che, se lui cerca di neutralizzare l’anomia prodotta dal Capitalismo che si vuole fare (realizzare come momento della prassi capitalistica) nel momento speculativo, l’ultima fase dialettica del suo ragionamento di alto contenuto filosofico, attraverso la neutralizzazione del principio fondante il capitalismo della dismisura con la misura , il secondo suo capitolo che parla della tradizione della misura appunto il contrapposto mondo greco quello aristotelico di economia(misura) contrapposto a crematistica(dismisura) per intenderci, non solo è un nostalgico dei propri studi e del proprio gusto e in questo non è in verità ma in volontà, ma esclude anche un elementare principio della tripartizione dialettica hegeliana, che il momento astratto della misura (Verstand)è stato appunto già superato da quello dialettico concreto della dismisura capitalistica.Non è che la sua è solo nostalgia dell’oikos ?
@Carlo:
Poco fa pensavo che ciò che davvero desidero non lo posso avere. E non è un modo di dire, ma so davvero che non lo posso “avere”. Che anche si trattasse ad esempio dell’amore – che potremmo considerare uno dei maggiori desideri – a maggior ragione non lo potrei avere.
Sono del parere che il mercato dei consumi abbia buon gioco nel proporci dei palliativi, che vanno a cercare di riempire i buchi di ciò che non potremo mai avere.
Comprendere questa cosa, però mi fa anche accettare il fatto di essere un essere sempre desiderante e mancante. O meglio, se non riesco ad accettare di essere fondamentalmente insoddisfatto, mi dispererei di questa cosa, invece di considerarla il mio modo di essere, se non perfino un’energia che si protende verso il futuro.
Non sono sempre sicura se considerare il desiderio una malattia o un’energia. Ma forse questo dipende dall’entità del desiderio, che deve essere esaminato “da un duplice punto di vista, secondo quantità e qualità”. (Marx)
Di essere schiavi degli oggetti che possediamo, era emerso anche nel gruppo di discussione. Ed è una cosa di cui mi sono resa conto da un pezzo, per quanto non possiamo fare a meno di tutto.
…leggevo che si troveranno insieme Severino, Ferraris,e Giorello per discutere sul “nuovo realismo”.
Che avremmo noi (se avessimo) noi da dirli, a loro?
O siamo uguali a loro, alla fine, anche noi?
che siamo uguali lo considero incontrovertibilmente, non potremmo comunicare altrimenti… anzi, mi spingo oltre, siamo un tutto del tutto visto ologrammaticamente.
noi non combattiamo per l’uguaglianza o per la fratellanza, noi combattiamo, contro natura, per la libertà. L’uguaglianza e la fratellanza è ciò che siamo.
«Il rapporto fra disciplina e libertà è profondo e importante: lungi dall’essere il contrario della libertà, la disciplina è ciò che rende possibili le più alte forme di libertà. Senza disciplina non c’è autentica libertà, c’è solo licenza. » (Mark Rowlands, Il lupo e il filosofo. Lezioni di vita dalla natura selvaggia. – Mondadori 2009)
@Rozmilla
Emanciparsi dal “desiderio”. Questa è la questione dirimente, rispetto al tema. Il desiderio ci rende deboli. La forza con cui ci assilla è il grande “mistero” della vita. Da questa traggono vantaggio i venditori di ogni risma e di ogni latitudine.
Un giorno osservai un colombo corteggiare la “colombella”. Sembrava impazzito. Gonfiava il collo e incalzava la malcapitata che, a sua volta, cercava di distanziarlo inutilmente.
Pensai che quel “dover essere” ri-duceva anche noi umani a marionette, i cui fili erano strettamente nelle mani del burattinaio “Desiderio”.
Ci sentiamo “carenti” e cerchiamo un completamento che l’esperienza ci insegna essere improbabile. Bisogna imparare a convivere con quel vuoto che ha ispirato poeti e filosofi.
Sì, credo anche io che siamo ormai tutti uguali, i pensieri che si produce sono sempre gli stessi pensieri, uguali, impossibile uscirne fuori…
Cosa è, allora, che ci fa continuare a manifestare i pensieri che si pensa (o che si crede di pensare)?
@Carlo:
Il desiderio ci rende deboli. Ma non potremmo nemmeno vivere senza desiderio. Siamo fisiologicamente vincolati alla nostra natura basica, e per emanciparci dal desiderio dovremmo superarla.
Comunque, “emanciparsi dal desiderio” potrebbe sembrare un’ottima cosa, se riuscissimo a realizzarla: tutte le religioni hanno sempre cercato di perseguire questo tipo di emancipazione, tenere a bada il desiderio naturale, gli istinti, o regolamentarli, anche se questa cosa può aver presentato il rovescio della medaglia. Ma anche per Freud l’emancipazione consiste nel sublimare la libido.
Indubbiamente ci sono differenti età nella vita, ognuna con esigenze diverse; perciò se emanciparsi dal desiderio può essere facilmente raggiunto da un adulto, l’emancipazione è difficilmente proponibile ad un giovane, almeno non negli stessi termini. Il problema però è che nella nostra società opulenta ed edonistica, molto spesso non viene accettata nemmeno dagli adulti.
Dovrebbe necessariamente giungere un momento in cui gli adulti abbandonano le cose infantili, civilizzano i propri istinti e crescono. Diventare adulti significa deporre le vesti di figlio/a e mettersi quelle di padre/madre. Ma se i figli non sono in grado di diventare genitori, i figli dei figli non potranno crescere vigorosi. Che difatti oggigiorno il raggiungimento dell’età adulta molto spesso è rinviato ad un tempo indefinito – la sindrome di Peter Pan sembra essere molto diffusa.
Ma quando parliamo di desideri, si parla di un campo molto vasto, non soltanto del desiderio inteso come libido, anche se la libido probabilmente è alla base di ogni desiderio. La libido è il fuoco originario. Il fatto è che quando si sviluppa, procede in direzioni diverse al punto da farci persino dimenticare l’origine, o mette in atto comportamenti aggressivi. Come un incendio che divampa in ogni direzione. È così è stato.
Nella specie umana sembra essere connessa all’aggressività e alla violenza, mitigata più o meno debolmente dalla morale, sempre imperfetta come ogni cosa umana. Lo sviluppo della morale dovrebbe (o avrebbe dovuto) funzionare come inibitore, per evitare la distruzione della specie stessa.
@tutti
un poco di chiarezza si da non continuare sulla strada dei punti di vista ma di rifletterci, poiché riflettere sui punti di vista non è un punto di vista, vero? (Severino)
L’impressione di chi legge , fin da MD per andar giù in fondo a Rozmilla, è di un gruppo di persone che non si interrogano sull’origine del desiderio e che quindi non fanno filosofia, ma piuttosto hanno il desiderio di capire dove è l’entrata dell’autostrada che ci porta alla riflessione appunto, all’origine, a risolvere la fatidica domanda: perché l’uomo desidera ? Se l’uomo non avesse paura desidererebbe comunque? il desiderio è uno stimolo pre-cosciente ? l’uomo è giunto a definire che oltre un certo limite non può più consumare ? Questo dato in lui ha aperto un conflitto dell’infinito nel finito ? Ansia di completamento qui subito sulla terra? il desiderio è quella parte del tutto che , siccome mi manca mi completa, è la soluzione alla contraddizione della parte nel tutto , tutto qui.
@Alessandro Vaglia:
qui si fa filosofia eccome, e ad alti livelli, che in giro per accademie te li scordi (e non certo per merito mio) e questo succede ininterrottamente da quasi 6 anni, e non solo ci si interroga sul desiderio, sulla natura umana, sul perché di ogni cosa (questioni che non hanno certo bisogno dell’imprimatur severiniano per attingere la radicalità del domandare), ma anche sul senso stesso di quel domandare radicale, e su quella che Hegel definisce da qualche parte “Begierde”, brama incontenibile di conoscere – una forma di desiderio al quadrato.
La tua è, appunto, una semplice “impressione”.
Vedo che leggi e addirittura prendi le difese del tuo ego, oh, finalmente si dà a Cesare quel che è di Cesare a Dio il suo… sono certo che l’impegno è forte e altrettanto la discussione, ma il tono di una discussione non fa l’essenza della medesima. Se scrivo sul suo blog MD è perché è lei che cerco e in qualche modo anche filosofiazzero , il mio desiderio appunto è quello di completarmi con lei, almeno per ciò che concerne questa transizione.
leggo i commenti fino in fondo solo quando non cominciano berciando o supponendo (nel senso della supponenza) troppo per i miei gusti (e desideri);
dopo di che, gli interlocutori, in un blog come in un’assemblea pubblica, non possono essere scelti o preventivamente selezionati;
si discute con chi c’è o con chi ha voglia (desiderio) di farlo, oppure non si discute, o si finge di discutere, o si afferma il proprio ego, o… varietà del molteplice, insomma!
@rozmilla
Andare oltre il desiderio è possibile? Sarebbe una forma radicale di snaturamento. Diventeremmo “altro” rispetto alla nostra natura basica (un corpo dotato di funzionalità cognitive). Cosa, dunque, possiamo fare in concreto? Proposta banale: fare leva sull’ intelletto per mettere le briglie, per dare una “regia” coordinatrice alle pulsioni incontrollate (prepotenza del desiderio) che ci agitano. Insomma dobbiamo civilizzarci, divenire cittadini della “πόλις”. Individui eticamente sensibili. Per questo occorre l’educazione (educĕre, cioè “tirar fuori” dal caos istintuale la ratio, quel “quid” che connota l’umano). Quindi, occorrono “buoni maestri”, che ci ricordino quotidianamente che ogni cosa ha il suo limite e che questo deve essere l’oggetto fondamentale della nostra riflessione quotidiana. Dove si approda se imbocchiamo questo faticoso percorso? inevitabilmente ad un progetto filosofico che, se ben gestito, ci segnerà per sempre. Ecco perché è indispensabile l’ “educazione al pensiero” in ogni ordine e grado delle nostre scuole pubbliche. Attenzione: le terapie filosofiche civilizzatrici sono tante. Possiamo pensare a fondo perduto sull’essere oppure possiamo con-cludere che il non-pensare consapevole (astenersi dal giudizio cogente), dopo avere adeguatamente pensato, sia il minore di tutti i mali dell’essere, il progetto meno invasivo rispetto al mondo che ci ospita.
“…di natura artificiale, se poteva che esistesse, natura vera, o soltanto tutto falso, solamente aberrazioni, incrostate nel cervello. incluso le finzioni filosofiche, più o meno, si capisce, rigorose, idiota, anni e anni buttati via, ce ne fosse positivi, nella vita.”
@ Carlo:
Nel corso degli anni in varie discipline orientali ho trovato molti modi di descrivere l’emanciparsi dal desiderio, come “svellere le radici della selvatichezza”, o “mettere le briglie ai sensi”. C’è anche una bella metafora nelle metafisiche indiane (ora non riesco ad essere più precisa) che paragona la disciplina necessaria a diventare uomini all’apprendistato di un nocchiero che deve imparare a farsi obbedire dai suoi cavalli. La mente è il nocchiero sulla biga che tiene le redini ai cavalli. I cavalli sono la forza motrice, ma è il nocchiero che li tiene in pugno e li guida. Viceversa, se il nocchiero si facesse trasportare dai cavalli senza tenerli a bada, possiamo immaginare che alla prima curva la biga si rovescerebbe catapultando fuori il nocchiero.
Non credo che si possa snaturare totalmente un essere umano, senza che questo comporti svilimento e sofferenza della nostra natura animale. La natura (diciamo) animale deve essere come addomesticata, disciplinata: solo così possiamo conviverci senza averne dei danni, sia personali che sociali. E solo dopo si può procedere all’educazione del pensiero, della ragione – a mio avviso.
Nella nostra società postmoderna, sulla scia della liberazione mal intesa, si è confuso la libertà col libertinismo, o lecitazionismo, per cui libertà ha significato lasciar fare con l’obbiettivo di ottenere il maggior piacere immediato, sia per i giovani che per gli adulti – che così potevano evitare la fatica di dover insegnare la disciplina e far rispettare le regole (che neppure essi stessi volevano più rispettare). Ma il permissivismo non è stato il miglior favore che abbiamo potuto fare né a noi né ai giovani. Se l’autoritarismo era sbagliato, perché violento, non rispettoso e imposto in modo coercitivo, il lecitazionismo è stato il danno opposto.
Anno di nascita ‘58, quindi ho vissuto tutto questo bel periodo di “liberazione” dalle regole e dall’autoritarismo, che ha coinvolto tutta un’epoca in modo trasversale, al punto che le stesse istanze libertarie sono diventate in breve una nuova schiavitù da quella stessa libertà che si voleva conquistare. E abbiamo visto anche in campo politico e capitalistico-finanziario, quante belle conseguenze ha provocato.
Dopodichè – questa è la mia esperienza personale – la prima più importante occasione per apprendere la disciplina mi è stata offerta dallo yoga. Per questo sono del parere che l’educazione debba iniziare dal corpo, radicarsi nel corpo, sradicando dal corpo la selvatichezza, per cominciare. L’addestramento deve rendere il corpo, e la mente, docili e aperti a quello che si potrà imparare. Smorzando l’ego, che si erge arrogante (tipico dell’età giovanile), in un corpo scomposto, nemmeno capace di stare fermo e diritto. E chiaramente i buoni maestri sono importanti per l’esempio, la determinazione, la fermezza, la cura disinteressata. Si arriva a un punto in cui la nostra testardaggine cede, si comprende che non si ha altra scelta che fidarsi, che è l’unica opzione possibile, l’unica cosa giusta da fare.
Uno degli aspetti della pratica è imparare a rinunciare. Sottrarre al corpo quello che naturalmente vorrebbe desiderare. Diminuire il cibo, anche con digiuni, e l’aria, e resistere al caldo, al freddo, alla fatica. Tenere posizioni che all’inizio possono essere scomode, sempre più a lungo. Chiudere tutti i fori (i fori dell’orcio). Tacere. Osservare i propri pensieri come cose che passano, e diventare colui che li guarda. In una parola controllarsi in tutti i sensi. E ripulirsi. La pratica comprende il disintossicare il corpo anche dal dolore accumulato negli anni, quindi dalla paura.
La pratica yoga, per quanto ora non lo pratichi più, mi ha segnato per sempre. In seguito c’è stata la filosofia. Solo dopo.
Chiaro che ognuno di noi ha sperimentato percorsi diversi; ma se qualcuno crede che basti leggere libri di filosofia, o ascoltare uno o l’altro insegnate, senza essere pronti in un altro senso, ovvero se non si è ancora sradicato l’egoismo che ci fa sentire al centro del mondo, per cui è più importante solo “l’io” e io, e io … si rimane chiusi nella gabbia dell’io e non si procede, non s’impara niente né si cresce. L’unico modo per trovarsi è quello di perdersi. Ad esempio perdere quello che crediamo di essere, ma che non siamo.
Provocazione… Non è che invece Rozmilla bisognerebbe ricominciare a ritrovarsi invece di continuare a perdersi ? l’anomia implicita nella filosofia capitalistica gode di un desiderio libero da ogni soggettività.
ma certo che bisogna cominciare a ritrovarsi … che infatti è quello che ho scritto: perdere quello che non siamo per trovare ciò che siamo …
Ciò che segue, è tratto da un capitolo del mio libro che si intitola appunto “Bisognie desideri”, in cui mi pare di affrontare l’argomento in maniera originale.
“La persona umana, quale essere biologico, ha una serie di bisogni. Questi però non si presentano alla coscienza nella loro spoglia essenzialità, ma travestiti da desideri. La nostra riflessione cosciente, anche la più approfondita introspezione, poiché si esprime sotto forma di linguaggio, non può accedere a questa dimensione primordiale. Definisco appunto desiderio una manifestazione cosciente di bisogni inconsci, precisando che in tale definizione non è sottintesa alcuna corrispondenza biunivoca tra bisogno e desiderio: un bisogno può dare luogo a una molteplicità di desideri, come anche un desiderio può essere il prodotto di più bisogni.”
Seguono alcune esemplificazioni e mi occupo successivamente di specificare quali modalità possano permettere di riconoscere alcuni dei nostri bisogni, ammettendo senz’altro che sia impossibile riconoscerli tutti.
“…nel sentire comune, sembra addirittura una banalità, i desideri sono lì per essere soddisfatti. Del resto, non riesce forse spontaneo mettere in atto tutto ciò che è possibile per soddisfare i propri desideri? E’ evidente che se il desiderio è espressione cosciente di bisogni, dall’apparizione della vita la selezione naturale ha operato perché gli individui riconoscessero come prioritario il soddisfacimento dei propri desideri.”
“Tuttavia, se perfino il bisogno di alimentarsi può dar luogo a una fame eccessiva, si può ipotizzare che altri bisogni meno riconoscibili diano luogo a una molteplicità di desideri, e che, perché il bisogno sia soddisfatto, non sia necessario, se non addirittura dannoso, soddisfarli tutti. Del resto, sapendo quanto numerosi siano i desideri, quanto questi si possano moltiplicare in contesti che tendano a suscitarli (la cosiddetta società consumistica), è ragionevole supporre che i desideri siano molto più numerosi dei bisogni, essendo questi legati alla nostra inamovibile biologia, e considerando quanto inefficiente sarebbe una specie che avesse un numero elevato di bisogni.
La conseguenza che trovo più rilevante è lo spezzarsi dell’automatismo che lega il desiderio al suo soddisfacimento”
“Se quindi è lecito desiderare, potrebbe non essere opportuno soddisfare tutti i desideri. Anzi, si può addirittura ipotizzare che esiste nell’uomo anche un bisogno di desiderare. I desideri non vanno quindi visti come dei semplici problemi da risolvere, ostacoli da superare, ma vanno anche considerati come fine a sé stessi.”
Per maggiore chiarezza, potete direttamente leggere il libro…
Stavo pensando che prima di tutto dovremmo fare una distinzione fra “desiderio” e “desideri”. Desiderio è la facoltà di desiderare, i desideri sono le cose desiderate, che possono essere cose di cui abbiamo davvero bisogno, o cose di cui invece non avremmo bisogno se non fossimo indotti a desiderarle.
In una parola se non fossimo “imbrogliati”, ingannati dagli stimoli che provengono dalle pubblicità, che oltre ad offrirci delle semplici cose, cercano di venderci un intero stile di vita.
E «se, come dice Harry Franckfurt, “essere liberi significa essere stimolati dai desideri da cui vogliamo farci stimolare”, allora la persuasione del mercato non ha nulla a che fare con la libertà.
Non è una questione di “falsa coscienza”, ma di seconda coscienza (ciò che vogliamo desiderare), che ha la meglio sulla prima coscienza (ciò che desideriamo)». [B.R.Barber, Consumati. Da cittadini a clienti. (Einaudi, 2010) pag. 322]
Notare nella frase qui sopra l’espressione di “prima” e “seconda” coscienza, indice di una manifesta schizofrenia. Quindi, chi siamo noi? Cittadini o clienti?
@Rozmilla
Il punto è che non dovremmo fare saltare la distinzione di principio tra bisogno e desiderio, si parla a mio parere di entità di differente natura, che non possono essere assimilate le une alle altre.
Gli esempi che si possono fare sono molteplici, come il desiderio sessuale a cui non corrisponde un bisogno sessuale, ma semmai il bisogno di sopravvivenza della specie. oppure potremmo citare il desiderio di correre dei bambini a cui corrisponde il loro bisogno di crescere muscolarmente, e si potrebbe continuare ancora.
Desiderare sarebbe quindi un meccanismo tra altri di cui sono forniti gli esseri biologici per i fini di sopravvivenza individuale e della specie a cui appartengono.
Ciò tra l’altro ci permette di esentarci da un processo valutativo, di distinguere quindi tra desideri classificandoli in livelli qualitativamente differenti, un processo sempre rischioso culturalmente influenzabile, di modo che ciò che oggi viene valutato come un desiderio giusto, domani potrebbe essere valutato come sbagliato.
Inoltre, c’è un ulteriore elemento che dovrebbe scoraggiarci da un simile approccio, il fatto che uno stesso desiderio si confronta con un livello quantitativo di soddisfazione. Esemplificando, mangiare per duemila chilocalorie per un maschio adulto è lecito ed anzi necessario, ma mangiare per tremila chilocalorie è sbagliato e nuoce allal salute.
Sono tutti problemi che dovrebbero suggerirci di tenere ben separati tra loro i concetti di bisogno e di desiderio (che in ogni caso non può coincidere con l’oggetto desiderato, come lo sguardo rivolto a una persona non può ovviamente coincidere con la stessa persona).
Aggiungerò ancora qualcosa.
Tutto il mio ragionamento porta a una conclusione.
Il meccanismo del desiderio funziona egregiamente in un ambiente in cui le risorse sono scarse, come è norma negli ambienti naturali. Infatti il desiderio non sta lì per essere soddisfatto, ha solo una funzione strumentale per essere talvolta sioddisfsatto, non sempre e neanche abitualmente soddisfatto.
In un ambiente antropizzato, in cui sdalta la condizione di scarsità di risorse, quello stesso meccanismo desiderativo fallisce, si ritorce contro lo stesso individuo, e ciò spiega anche perchè un ambiente con risorse abbondanti possa diventare persino insopportabile: ci si suicida dove si è ricchi, non dove si è al limite di sussistenza.
Questo è uno degli elementi di base che mi supporta la necessità di una svolta verso una società più sobria di quella attuale. Naturalmente, è necessario meglio specificare le caratteristiche spoecifiche di tale società.
@ Vincenzo:
“non dovremmo fare saltare la distinzione di principio tra bisogno e desiderio”
Non voglio far saltare niente. Anzi, sì, vorrei far saltare molte cose, ma non le distinzioni. E perché mai? E d’altra parte anche nel tuo testo non converti i bisogni in desideri, o viceversa?
Direi invece che ho fatto la distinzione che avrei dovuto fare fin dall’inizio, fra il desiderio (come facoltà) e i desideri (come i molteplici desiderata)
Ho letto il tuo testo, e a mio parere il tuo approccio alla questione è fin troppo moderato. A me ad esempio sta bene di moderare i bisogni, ma non di moderarmi troppo nel moderare i bisogni. E nemmeno di moderare “il” desiderio – che anzi è fin troppo sciapo, carente, per cui a parer mio avrebbe bisogno di essere rinforzato e indirizzato in altre direzioni, ad esempio nel voler cambiare …
Così, ad esempio quando scrivi: “potrebbe non essere opportuno soddisfare tutti i desideri”, secondo me bisognerebbe essere più incisivi e meno dubbiosi in proposito. E piuttosto direi un bel tosto: soddisfare tutti i desideri che vi hanno indotto a credere di avere è praticamente inutile oltre che impossibile, e rincorrere questo fine in breve tempo vi porterà a distruggere voi stessi e il vostro desiderio (se non l’ha già fatto)”.
E quando scrivi : “… ci permette di esentarci da un processo valutativo, di distinguere quindi tra desideri classificandoli in livelli qualitativamente differenti”, …. beh, io non desidero affatto esentarmi da alcun processo valutativo. Certo, si dà il caso che col tempo siano necessari e auspicabili degli aggiustamenti e dei perfezionamenti, ma non mi sembra questo il problema.
È una cosa molto semplice, ogni giorno possiamo scegliere secondo quello che ci fa bene e quello che ci fa male, ad esempio, o secondo quello che desideriamo piuttosto che quello che veniamo indotti a desiderare.
Considera che finora stiamo parlando di desiderio e soddisfacimento dei desideri a livello soggettivo, e non oggettivo. Quindi è un processo che chiama in causa la nostra libertà, indipendenza e capacità di non essere influenzati, condizionati dai dispositivi, fidandosi un po’ di più del nostro istinto (se non è estinto), senza trascurare però di leggere bene le etichette.
“è necessario meglio specificare le caratteristiche specifiche di tale società”: specificare le specifiche di una società, temo sia abbastanza inspecificabile. Semplicemente perché non credo sia attuabile fare un progetto specifico, al quale tutti devono essere costretti ad attenersi. Questa cosa non è fattibile, non può calare dall’alto. Ma per cominciare ognuno di noi potrebbe (se riesce, se vuole) ad esempio iniziare a cambiare le proprie scelte in fatto di consumi e di stile di vita.
@Rozmilla
Concordo su tutto.
Una postilla: il desiderio di un oggetto nasce dalla memoria del “piacere” che si è provato, esperimentando l’oggetto medesimo. Quel ricordo ha sedimentato una nostra dipendenza e, quindi, ha provocato una diminuzione della nostra libertà relativa.
Starà a noi valutare se l’oggetto (del desiderio) è cosa buona in sé oppure se noi abbiamo “mal interpretato”. Il potenziamento del libero pensiero (filosofico) serve, tra le altre cose, a questo.
@Rozmilla
ùTi rispondo solo su un punto, poi spero di tornarci con più calma.
Quando dico che dobbiamo esentarci da un processo valutativo, non dico che non dobbiamo valutare, al contrario, ma questo è il campo della politica, mentre qui affrontavo una tematica antropologica. Insomma, vorrei che lo schema teorico su cui tutto il resto poi si basa venga sottratto a una forma di discrezionalità. Quindi, qui intendevo soltanto distinguere due livelli di intervento, uno che descrive i meccanismi antropologici a cui siamo soggetti come esseri umani, e che dobbiamo prterservare dai nostri giudizi di valore, l’altro politico, in cui invece il processo valutativo deve operare liberamente, ma che è inevitabilmente soggetto a continue revisioni.
@Carlo:
Già, i nostri desideri sono contaminati da abitudini e dipendenze. Infatti non ci poniamo nemmeno il problema della scelta in moltissime cose. Continuiamo a fare ogni giorno quello che abbiamo sempre fatto, per abitudine, e questo è in relazione anche al bisogno di fare meno fatica. Cambiare, sradicare abitudini e dipendenze, può anche far male, insomma, e abbisogna di un surplus di energia e motivazioni appropriate. Che magari non abbiamo, perché è probabile che si viva al limite dell’indigenza, dell’impotenza, riguardo alla realizzazione dei nostri veri desideri – ciò che varrebbe la pena di desiderare, se avessimo qualche possibilità di realizzarlo.
Infatti, più che a provocare piacere, alcune abitudini e stili di vita finiscono per provocare dis-piacere, senza che però riusciamo a reagire, senza che abbiamo la forza per cambiare.
Il fatto di valutare una cosa migliore di un’altra, quindi, può restare una valutazione teorica, senza avere possibilità di essere realizzata in pratica. Come dicevi qualche commento fa, ci deve essere una molla – una molla che ad esempio permetta di mettere in atto quello che razionalmente abbiamo valutato più desiderabile, perché più buono. Ma quale molla? E come?
@Rozmilla
Quello di cui parli ha a che fare con la dimensione psicologica. Un “io” forte non tentenna, ma procede sulla strada della libertà, recidendo, con il macete della volontà, lacci e lacciuoli virtuali, paure che bloccano il suo “divenire sé stesso”.
Non un ego desiderante, ma un io propositivo, progettuale. Un io che può sempre accomodarsi nel suo corpo, come in una dimora felice, ma anche risvegliarsi ogni giorno a nuova vita. Appagato dalla luce del sole che gli comunica, all’alba, benefico, il senso dell’essere e non del mal-essere quotidiano. In pace con Madre Terra.
L’esigenza che pongo di non classificare, come ad esempio fa Epicuro, i desideri, parte proprio dall’esigenza che vedo prioritaria di distinguere tra bisogno e desiderio. Infatti, se seguendo Epicuro, classifichiamo in un ordine di priorità i desideri, ciò implica evidentemente la nostra capacità di riconoscere i bisogni, cosa che io rifiuto dall’inizio, pur ammettendo che qualcuno tra questi sia riconoscibile. Fa parte della mia impostazione filosofica complessiva, da cui discende questa consapevolezza dei nostri limiti nel campo della conoscenza.
Naturalmente, per scegliere quali desideri assecondare, non c’è bisogno di avere certezza sul loro grado di corrispondenza a bisogni obiettivi.
A me interessa soprattutto la dimensione collettiva, per questo dicevo che questo è un compito proprio della politica, che dobbiamo scegliere tutti assieme in un dibattito adeguatamente argomentato sapendo che errori saranno inevitabili e che quindi si tratta di scelte contingenti e reversibili.
L’alternativa, quella di stabilire tassativamente un elenco di bisogni, sfocia in una fede, e a livello politico in uno stato teocratico.
“…divenire sé stesso”(dell’uomo). Che vuol dire?
Giè, filosofiazzero, tutto l’ultimo intervento di Carlo non mi convince per niente, mi pare la quintessenza dell’individualismo occidentale che c’ha portato al punto in cui siamo.
Eppure, la nostra dimensione collettiva è suggerita da tutta una serie di evidenze. Mi pare che ciascuno di noi è sato educato ed istruito in uno specifico contesto storico-culturale, da cui è assolutamente impossibile prescindere, a partire dalla lingua che parliamo che non è un caso se viene designata come linguamadre. L’ignorare la nostra dimensione collettiva, credere che se ci liberiamo non si sa di cosa (l’unica vera liberazione è quella che si attua in noi stessi) accediamo a non so che paradiso, mi pare non solo errata ma perfino pericolosa.
Uno dei maggiori errori della religioni monoteiste sta proprio nel concetto di salvezza individuale: niente di più fallace, la salvezza può essere solo collettiva.
@Vincenzo:
Però finora stavamo ancora parlando del livello soggettivo, nella disamina dei bisogni eccetera.
Lo dice anche Md. all’inizio del post.
E poi comunque ognuno di noi vive sia la dimensione individuale che collettiva. Anche se nella nostra società a dire il vero si va verso una predominanza (abbondantemente indotta dal mercato dei consumi) dell’individualismo, con un indebolimento delle istanze collettive partecipative.
Ma aggiungo anche che lo stile di vita che facciamo ci indebolisce sempre di più, a mio avviso, anche a livello individuale.
Ed inoltre, qualsiasi azione o progetto collettivo, ha comunque bisogno che i partecipanti siano uomini anche individualmente sufficientemente forti, ossia che abbiano anche l’energia di procedere e portare innanzi un progetto collettivo.
Per questo credo che una cosa non debba escludere l’altra, ma che anzi le istanze debbano procedere su entrambi i fronti. Voglio dire, in linguaggio strategico militare: non puoi creare un esercito se prima con crei i soldati, come dire, i combattenti.
Quindi anche quello che ha scritto Carlo va tenuto presente e sviluppato, secondo me.
…ma tutti noi, sicuramente, restiamo, almeno, perplessi, quando qualcuno dice a qualcun’altro “devi essere te stesso”, che da una parte si può capire, da un’altra è un’assurdità.
@filosofiazzero:
E dove c’è scritto “devi essere te stesso”?
Carlo parla di un “io” forte che riesce a vincere le paure che bloccano il suo “divenire se stesso”.
Divenire se stesso. Ci sono sempre delle condizioni, comunque, che possono favorire o impedire il realizzarsi di quel “divenire se stesso” – che significa realizzarsi al massimo, o almeno al medio, delle proprie potenzialità. Anche Spinoza ne parla come una tensione a perfezionarsi.
Ma se uno non ha questa tensione? … allora resterà povero tapino? … o sono state le condizioni esterne che gli hanno impedito di perfezionarsi, se non persino impedito di sentire quella tensione?
…homini a bassa tensione?
L’individuo deve esprimere sé stesso in uno scenario collettivo. E’ un dovere morale emanciparsi dall’ignoranza e questo è uno sforzo che implica l’impegno personale. Più è alta la tua consapevolezza e la tua capacità di discriminare il vero dal falso, il bene dal male (relativo), più forte sarà la tua volontà di partecipare al “bene-comune”.
Ognuno di noi possiede “talenti” che devono essere valorizzati. l’individualismo è altra cosa rispetto all’individuo /persona.
Il primo ha a che fare con l’Ego desiderante, il secondo con l’io responsabile.
… tutti si appartiene a uno scenario collettivo, l’insieme di tutto quello che siamo noi, e gli altri (ivi inclusa la politica), costituisce il tutto entro cui. Che poi uno agisca per la trasformazione di questo tutto, rientra anche questo nel tutto suddetto (lo stesso Jonas compreso)
O è troppo “spinozista” un discorso di questo genere?
Poiché credo che in ogni caso l’energia di cui noi disponiamo è la stessa (thelos, conatus, pulsione vitale), la consapevolezza non fa che spostare ad un livello più alto ciò che è desiderabile, per cui non possiamo più essere appagati da piaceri di ordine inferiore.
Il dovere morale di cui parla Carlo diventa allora una necessità, qualcosa di cui sentiamo di non poter fare a meno, al punto che il proprio piacere immediato passa in secondo piano, rispetto alla necessità-dovere di partecipare e contribuire al bene comune.
“Sia la nostra vita fisica che quella sociale, i costumi, le abitudini, la saggezza che ci viene dalla conoscenza del mondo, la filosofia, la religione, e persino molte vicende casuali, tutto ci dice e ci ripete:
che noi dobbiamo rinunciare. […] Tuttavia, per fargli assolvere questo difficile compito , la natura ha fornito l’uomo di abbondante forza, attività e tenacia: In particolare modo, però, gli viene in aiuto quella legerezza indistruttibile che gli è stata conferità. E’ questo che lo rende capace di rinunciare in ogni momento a una cosa singola, perché egli possa nel momento successivo stendere la mano verso qualcosa di nuovo; e così inconsapevolmente ricostruiamo sempre ancora una volta la nostra vita. Sostituiamo ogni passione con un’altra, occupazioni, tendenze, predilezioni, manìe, tutto sperimentiamo per esclamare alla fine che è tutto vano. Nessuno si spaventa dinanzi a questo detto falso, anzi blasfemo, si crede persino di avere detto qualcosa di saggio e di inconfutabile. Sono pochi gli uomini che presagiscono tale intollerabile sensazione, e per evitare tutte le rassegnazioni parziali rinunciano una volta per sempre a tutto”
Goethe, che aveva letto un “libriccino” su Spinoza.
@filosofiazzero
Puoi far parte del tutto con la supponenza di marcare la discontinuità tra te e il resto del mondo (il marchese del Grillo: “io sono io e voi non siete un c…”. (scenario collettivo frantumato: “Ubi maior, minor cessat”). Oppure puoi riconoscere l’altro da te come co-inquilino dello stesso pianerottolo, riservandogli attenzione e rispetto (scenario collettivo coeso). Spinoza docet.
@rozmilla
Mi togli le parole di bocca.
I piaceri di “ordine inferiore” sono un lascito della natura, che l’ego enfatizza a dis-misura, con conseguente “schiavitù dei sensi” (dipendenza dal biologico).
Alzare il tiro, rispetto all’ordinario, al “si dice”, al “così fan tutti”, consente all’essere umano di divenire sè stesso: homo sapiens sapiens. Un salto ontologico che rende felici gl’idealisti. Ma che non può impedire al minimalista di suggerire: attenzione, evitiamo che il “razionale” divenga un assoluto!. Primum vivere. Deinde philosophari (Aristotele, Hobbes).
…è quello che stiamo tutti facendo(impossibile non sia)!
O che tutti, tutti insieme, si incominciasse a essere meglio (o se stessi o anche meno) o un Governo Mondiale che assicurasse l’eguaglianza la solidarietà eccetra…cominciando magari dal nostro governo, se lo fosse possibile…(a partire ognuno dal suo pianerottolo)
E’ così che è giusto dire?
Cari Carlo e Rozmilla,
a mio parere a voi sfugge l’aspetto che invece io considero fondamentale, e cioè che l’unica cosa su cui possiamo intervenire è il contesto collettivo, il che coincide col fare politica.
Il punto cioè non sta nel riconoscere o non riconoscere se esista un aspetto individuale, quello ovviamente esiste, ma:
– intanto, è estremamente difficile intervenire a questo livello, perchè non si insegna a diventare e restare liberi, si tratta di conquiste individuali risultato di lunghe riflessioni e battaglie svolte nel proprio intimo.
– intervenire a questo livello credo che sia perfino pericoloso, in fondo tutti i regimi dispotici si sono basati sul possesso dell’anima della gente, e mi fa paura ad esempio la riflessione di Carlo sull’inferiorità dei bisogni biologici: caro Carlo, ci sono forme di condizionamento culturale che sono molto, ma molto più pericolose e dannose che non il semplice assecondamento delle spinte istintuali. Tali aspetti più istintuali sono dannosi soltanto a causa del contesto, in un contesto naturale, sono appropriate: quindi, andiamoci piano.
Quando osservo con quale facilità ho smesso di fumare, con quanta facilità mi sottopongo periodicamente a diete dimagranti che magari per chi mi sta attorno sembrano non proprio indispensabilli (non sono certo obeso), non v’è dubbio che sento il piacere di sentirmi capace di tale autodisciplina, ma dalle tue parole sembrerebbe che mi debba anche sentire superiore a chi non vi riesce, e questo per me è inaccettabile. Il diavolo si annida nei posti più impensati, sai…
@Vincenzo
La Politica con la P maiuscola (la nostra Costituzione) promuove, sulla carta, le condizioni per cui ogni cittadino possa vivere in modo libero e dignitoso (il che implicherebbe l’insegnamento a “diventare e restare liberi,” tramite la scuola pubblica). Se questo non accade, la colpa ricade interamente sulla classe politica, che, come tu sai, oggi, gode del massimo discredito.
Anche le riflessioni individuali possono portare alla crescita delle virtù personali e civiche, ma è un percorso accessibile solo a pochi, se manca il supporto di un contesto culturale favorevole. I bisogni del corpo devono essere adeguatament soddisfatti. Ma questo non esclude che, con un adeguato “training”, l’individuo possa mettere sotto controllo le pulsioni istintuali, non perchè “inferiori”, ma in quanto fuorvianti rispetto ad una vita libera e dignitosa.
Il giudizio sull’inferiorità dei bisogni biologici è prevalentemente appannaggio dei filosofi dell’Assoluto ovvero dello Spirito. Delle ideologie che promuovono lo Stato Etico. Lungi da me questa idea (platonica).
@ Vincenzo: quando parlo di “piaceri di ordine (o livello) inferiore” mi riferisco a ciò che nel mio percorso giungo a considerare inferiori, che credo sia qualcosa che accade anche “naturalmente”, col passare degli anni, nelle varie età della vita, alle quali corrispondono scelte personali differenti. Ma, lungi da me l’idea di applicare agli altri la mia scala di valori. Ognuno è dove si trova, e sarebbe pericoloso sentirsi superiori o inferiori ad un altro, rispetto a ciò che consideriamo più desiderabile e appagante. Quindi è chiaro che questo discorso si riferisce ad un percorso individuale, di crescita personale.
E ad ogni modo Carlo ha già scritto in proposito molto meglio di me.
Anche se … se ad esempio fossi un insegnante, cercherei di favorire anche la crescita personale dei miei allievi in tal senso – così come madre cerco di farlo, per quanto ci riesco, nei confronti dei miei figli. E pur rispettando la condizione particolare in cui ognuno dei miei figli si trova, non ho dubbi di dover fare qualcosa per migliorare la loro condizione, il loro modo di essere e di comportarsi.
La responsabilità implica ovviamente la responsabilità verso chi è più piccolo. Altrimenti che responsabilità sarebbe? A cosa servirebbe?
Per esempio a me non dispiacerebbe uno stato un po’ più etico, rispetto ad uno stato palesemente immorale. Idem per la politica. Chiaro che l’ideale è qualcosa di ideale, appunto. Ma se non avessimo un qualche punto ideale sul quale regolare le nostre azioni, in che modo potremmo muoverci, agire? L’ideale indica la direzione verso cui andare. È come una mappa ideale, anche se poi il percorso lo dobbiamo fare sulla terra passo passo, verificandolo e trasformandolo dove e quando è necessario.
Comunque … la suddivisione dei piaceri, ossia di ciò che è desiderabile, in categorie superiori ed inferiori, ha storia antica.
A tal proposito riporto un brano tratto dal libro di Barber (già citato), il quale sottolinea come nella nostra società, sempre a causa dell’infantilismo indotto dai mercati, sia in aumento anche la tendenza ad ottenere soddisfazione e appagamento, da quei piaceri cosiddetti “facili”, rispetto a quelli difficili, che abbisognano di maggiore fatica ed impegno (anche personale).
«L’etica tradizionale (in Aristotele, sant’Agostino o Kant, per esempio) distingueva tra forme di piacere di categoria superiore e inferiore, ed affermava che ciò che dà piacere non sempre corrisponde a ciò che è bene.
Ma l’utilitarismo etico moderno di filosofi quali David Hume e Jeremy Bentham cercava di subordinare il “bene” a ciò che è meramente piacevole, per poi, semplificando, ridurre il piacere allo stimolo fisico elementare. Non operava nessuna distinzione fra forme diverse di piacere (o dolore), ritenendo che la felicità dipendesse soltanto dal massimizzare il piacere elementare e minimizzare il dolore elementare per il maggior numero di persone possibile. Ciò permise a Bentham, agli inizi del XIX secolo, di presentare un “calcolo felicifico dei piaceri e delle pene”, utile per quanto semplicistico, che associava ogni genere di condotta ed etica umana a indicatori del piacere e del dolore elementari, semplici e di facile interpretazione. Era bene ciò che induceva sensazioni positive o di benessere e implicava pertanto la presenza del piacere e l’assenza del dolore, secondo il minimo comun denominatore dell’esperienza sensoriale. La felicità era quantificabile. Ma qual era il suo grado di intensità? Per quanto tempo sarebbe durata? Quando sarebbe arrivata? Quanto certa era la sua realizzazione?
Questo significava che il piacere elementare che un bambino (secondo l’esempio freudiano) prova nel giocare con i propri escrementi era semplicemente un altro (largamente indistinguibile) esempio del piacere in senso riduttivo che un adulto può trovare nel suonare il flauto in una rockband afrocaraibica.
Lo stesso Jhon Stuart Mill, allievo di Jeremy Bentham, si oppose a questo genere di semplificazioni affermando la necessità di ammettere un’analisi discriminante dei piaceri, poiché ne esistevano di diversi tipi, alcuni più nobili di altri, altri facili, altri più difficili, alcuni semplici, altri più complessi, alcuni infantili, si potrebbe dire, altri più evoluti. A suo avviso non tutti i piaceri erano omogenei e tra loro commensurabili: esattamente come le mele e le arance, o le feci e i flauti, essi si distinguevano per qualità e quantità. Alcuni piaceri erano da preferire agli altri perché offrivano soddisfazioni “più elevate”, ottenuti in virtù di un lavoro più duro e uno sforzo più disciplinato, e generavano pertanto forme di felicità più complesse e più appaganti. Come in Aristotele, la scala di valori di Mill attribuisce ai piaceri difficili e complessi un valore più alto rispetto a quelli facili e semplici. Nel suo celebre aforisma, affermava che il piacere di leggere poesia è preferibile a quello del gioco della pulce, perché la felicità richiede di abbracciare la massima epicurea che ci esorta a “cambiare il piacere più facile con quello più difficile”, perché “i piaceri difficili sono più appaganti”. »
[Benjamin R. Barber, “Consumati. Da cittadini a clienti”, Einaudi (2010), pagg. 126-127]
Cari Carlo e Rozmilla,
mi sento un po’ frustrato, in quanto ho l’impressione di non essere letto.
Io non dico:
– che esista un metodo obiettivo di classificazione dei desideri
– non dico tuttavia che non se ne debba discutere, anzi una società non può prescindere dall’affrontare tali tematiche collettivamente.
Il punto è che stilare un ordine assoluto di merito dei desideri apre le porte alle fedi con tutto ciò che questo porta dietro.
Ribadire tuttavia la dimensione collettiva significa per me porre una critica spietata alle società liberali, quella in cui viviamo compresa.
Quindi, pur riconoscendo che debba sempre esistere uno spazio individuale da preservare accuratamente, non poso convenire con il liberalismo che fa della morale un fatto individuale, è la società che deve farsi carico di stabilire quali tipi di desideri debbano avere una tutela sociale, un’etica collettiva esiste in ogni caso, dobbiamo solo stabilire se tale ethos debba essere stabilito collettivamente o da pochi che, avendo mezzi economici e mediatici adeguati, possano manipolarci allo loro piacimento.
In risposta, mi citate la nostra costituzione (liberale) e un passo che riporta le tesi di alcuni dei più importanti teorici liberali…
@Vincenzo
Perchè critica “spietata” e non, piuttosto, costruttiva? Le società liberali sono probabilmente il meno peggio, se veramente “liberali”.
Al loro interno possono trovare spazio alcune tutele per la protezione dei più deboli, senza creare scandalo.La nostra Repubblica, ad esempio, non è certamente una società liberale compiuta, ma solo abbozzata. Non privilegia il merito, ma l’appartenenza a bande, che ti offrono prebende se ti adatti a servirle.
@Vincenzo:
“mi sento un po’ frustrato, in quanto ho l’impressione di non essere letto”
È la stessa impressione che ho avuto anch’io … quindi abbiamo qualcosa in comune.
Quindi ti assicuro che nessuno ha mai parlato di stabilire un ordine assoluto di merito dei desideri, né che sia necessario un metodo oggettivo. Se ne stava parlando, appunto.
Poi:
“non poso convenire con il liberalismo che fa della morale un fatto individuale, è la società che deve farsi carico di stabilire quali tipi di desideri debbano avere una tutela sociale.”
A parte che la società è formata dagli individui – si spera, quando però non sono sudditi o schiavi, e già su questo punto ce ne sarebbero di cose da dire – e a parte che è molto difficile “stalilire” quale debba essere l’ethos collettivo – visto che evidentemente siamo manipolati – allora, ancor prima di “stabilire” mi accontenterei di mettere in evidenza le problematiche di un ethos che ci sfugge di mano, e per quali motivi. E che sfugge anche alla politica, ahimé.
E comunque, i desideri che dovrebbero avere una tutela sociale, in campo politico solitamente diamo loro il nome di “diritti”. O sbaglio?
E comunque, se può rassicurarti, già eri avevo scritto alcune cose che non avevo inviato.
L’individuo dovrebbe poter esprimere sé stesso in uno scenario collettivo (lo scriveva Carlo qualche commento fa).
…. ma che tipo di espressione ci potrà essere qualora l’individuo vivesse in una società in cui, anziché venir favoriti gli individui in seno alla comunità, ci fosse ancora in atto la lotta di tutti contro tutti? o di gruppi contro gruppi? Nel qual caso il comportamento più “naturale” per ogni individuo (o gruppo) non potrebbe che essere quello di cercare di sopravvivere ingannando e opprimendo gli altri così come gli altri opprimono e ingannano lui?
Finché non esiste una coesione sociale per cui gli individui si sentono e sono parte integrante della società, dove ognuno lavora sia per se stesso che per il bene comune, e per cui il suo proprio bene non si discosta dal bene comune, è difficile che le cose possano evolversi in positivo.
Tornando ad uno dei temi del post, il vero lenone nella condizione sociale è il potere indiscusso del mercato capitalistico-finanziario che sprigiona la più grande potenza distruttiva assoggettando gli individui, e le comunità, rendendoli schiavi all’unico fine di aumentare indefinitivamente quello stesso potere.
In definitiva, risultiamo tutti vinti e impotenti, compresi i funzionari di quel potere. Trovo così assurdo che certi individui e corporazioni cerchino di aumentare in modo indiscriminato quel loro potere, totalmente fuori di senno di senso e scopo. Un potere che vuole aumentare talmente se stesso, fino al punto di autodistruggersi. E tutto questo non ha alcun fine e scopo razionale, è del tutto irrazionale: l’irrazionale che diventa reale. L’unica spiegazione è che tutto ciò sia la manifestazione di un palese impulso di morte.
Possiamo inoltre osservare come il sistema capitalistico lavori per disgregare la coesione sociale e impedire la crescita di individui integrati e consapevoli, e come l’aumento dell’individualismo faccia il miglior gioco per il mercato dei consumi.
Più gli individui sono soli, disgregati, meno capacità hanno di opporsi al potere del mercato. Le loro scelte, per quanto eroiche, restano sporadiche e non hanno alcuna possibilità di incidere e contrastare quel potere.
“Possiamo inoltre osservare come il sistema capitalistico lavori per disgregare la coesione sociale e impedire la crescita di individui integrati e consapevoli, e come l’aumento dell’individualismo faccia il miglior gioco per il mercato dei consumi.”
Che fare? Praticare il miglioramento indivuduale e/o circoscritto all’ambito circostante potrebbe essere negativo in quanto troppo individualistico e favorirebbe alla fine il sistema capitalistico. Partecipare alla politica sarebbe partecipare alla politica la cui regia, in realtà, è in mano al potere (sempre capitalistico-plutocratico-finanziario) Uno Stato etico, o un non-Stato, ma rischiando sempre che fosse il “potere” che se ne avvantaggiasse? Votare Bersani ?Banale. Non votare? Già fatto! Riunirsi a Rescaldina, alla Biblioteca Comunale per “affrontare tali tematiche collettivamente”? Come?
in effetti occorrerebbe forse ripartire da alcune definizioni di base, che non sempre sono condivise (quindi, figuriamoci, se già talvolta non siamo in grado di condividere le definizioni, hai voglia a condividere il resto…) – comunque: che cosa intendiamo per individuo? per società? per comunità? ecc. ecc. (e dunque, conseguentemente, per bisogni, desideri, ecc.) e quand’anche dicessimo – com’è ovvio dire – che individuo e società sono dialetticamente connessi ed inscindibili (un individuo è sempre un individuo sociale, così come una società è sempre una società di individui), non è che abbiamo proceduto granché…
Stessa cosa per quanto concerne la relatività storica dei bisogni – mutevolissimi per loro natura.
Spinoza però ci pone una domanda: poiché esiste un’invarianza antropologica (e “naturale”, dunque biologicamente determinata, con tutte le pinze del caso su tale determinazione) nella connotazione del desiderio (e degli “affetti” connessi), quali risposte razionali siamo in grado di dare come società (e, ormai, direi come specie) per evitare che l’irrazionale e la follia diventino reali?
Che fare? (praticamente, politicamente) è la domanda che sempre ci poniamo, e che sempre ci appare enorme (appare incongruente ed eccessiva a noi come singoli, di fronte a potenze quali possono essere quelle finanziarie o tecnologiche o ambientali od anche demografiche e culturali). Tuttavia da questo domandare e ragionare non si può prescindere. Se già cercassimo di reindirizzare il corso politico italiano (pur piccolo nell’economia globale, certo) verso modalità più razionali e meno “di pancia” (con annesse proliferazioni di vani desideri), sarebbe già qualcosa…
…appunto!
Mario, potrei riassumere (scherzosamente, sperando che non ti offendi) il tuo intervento dicendo “che bello dialogare giusto per il gusto di dialogare, ma garantendosi nella maniera più assoluta di non giungere ad alcuna conclusione (sennò, di cosa parleremo la prossima volta?)” 😀
Davvero, non credo che in questo caso ci sia un problema di mettersi d’accordo sul significato delle parole, mi spiace, ma non trovo stavolta il tuo intervento molto difensivo.
@Rozmilla
Eh no, non facciamo però i furbetti.
Qui, c’è in gioco una questione che non è affatto nominalista, se come dicono i liberali seguendo Locke, l’individuo preceda la società, o al contrario se la società preceda l’individuo.
Non è come l’uovo e la gallina, non scherziamo.
Locke in sostanza parla di un uomo che a un certo punto decide di costituire la società, e così la sua preoccupazione principale è quello di garantirgli le libertà di cui egli godeva prima di costituire la società.
I comunitaristi invece, ed io tra questi, pur non considerandomi un comunitarista, sostengono una tesi opposta, che cioè la società preceda l’individuo. Naturalmente, stiamo riferendoci all’individuo culturale, non all’individuo biologico che ovviamente viene prima. A Locke cioè sfuggiva che le due entità non coincidono, non è che l’uomo quando nasce, nasce già come essere culturale, è solo in quanto membro di una società a cui appartiene per nascita e senza sua volontaria adesione, ha una madre che gli insegnerà la sua lingua e i suoi costumi. Da questa cultura, ci si potrà distanziare, ma mai e poi mai essa potrà essere annullata, rimarrà una traccia indelebile, qualcosa che ci porteremo per tutta la vita. In alcuni casi, addirittura non vi è che riversamento della cultura colelttiva nell’individuo che sarà incapace di una sua autonomia di giudizio.
Per queste ragioni, la società non costituisce un pericolo, un danno inevitabile per l’individuo, come sostengono i liberali, che per questa ragione sostengono lo stato minimo “meno stato c’è, meno danno si crea”. Al contrario, la società fonda l’individuo, ne è la fonte di esistenza in quanto gli trasmette questo patrimonio culturale. Il punto insomma è che noi prima che esseri liberi, siamo esseri sociali. Ignorare che il signor Barilla con la pubblicità martellante possa imporci di consumare le sue orribili brioscine, significa essere inermi verso chi ha mezzi economici e mediatici per influenzare i suoi simili.
Come vedi, la questione non è afaftto banale e meno che mai nominalistica.
Mi fermo qui per il momento (non ho tempo per proseguire), ma tornerò.
@Vincenzo: beh, ma che c’era da difendere?
Piuttosto trovo semmai inconcludente questa perenne discussione sulla società e sull’individuo – è ovvio che si danno insieme e che soprattutto mutano insieme (e tra l’altro occorre non fare confusione nemmeno tra stato e società, cose diversissime tra di loro).
Beh, Vincenzo, se il mio intervento non è difensivo, è perché non ho alcuna percezione di dovermi difendere. Difendere cosa? E da cosa?
Non penso nemmeno che le nostre (mie e tue) opinioni siano poi tanto divergenti, mentre è più probabile che sia solo una carenza di informazioni, dovuto anche alla difficoltà di esprimere per intero tutto il proprio pensiero in una manciata di parole e una decina di commenti, che nel precedente dialogo (in particolare fra me e Carlo) si è soffermata sugli aspetti soggettivi delle dinamiche del desiderio, senza peraltro averle esaurite, perché ce ne sarebbero di cose da dire, a iosa, sulla natura e l’origine del desiderio, e sul perché e il percome siamo giunti dove siamo.
In realtà, il fatto che tu ti sia inserito, facendoci notare che non è questo il modo di affrontare il problema, ha impedito di poter concludere la discussione che stavamo analizzando dal punto di vista del rapporto piacere-desiderio-successo riproduttivo, e conseguente violenza che pervade la nostra società umana, e dove la morale si è rivelata l’unica strategia evolutiva che ha potuto mitigare l’aggressività innata della specie homo-scimmia.
È come se noi fossimo stati intenti a cucinare un cuscus antropologico, e tu vieni a dirci, no il cuscus non va bene, buttate via il cuscus e facciamo un minestrone politico. Certo, possiamo anche cucinare un minestrone – anche – ma intanto noi stavamo cucinando un cuscus, e non vedo perché dovremmo buttarlo via. Non vedo perché una cosa debba escludere l’altra, voglio dire.
Devo dirti però, che data la frequentazione di lunga data, per quanto mi riguarda mi sarei aspettata da te un po’ più di credito rispetto alla complessità delle mie opinioni, che non si possono liquidare certamente con l’etichetta di liberismo. Anche perché è chiaro che è anche nel liberismo del mercato che individuo uno dei nemici da combattere e dal quale ci si dovrebbe difendere, a livello pratico, e al quale si dovrebbe politicamente porre dei limiti. Ma ovviamente quello è un altro discorso, che non dico che non possa essere affrontato. Ma è e resta un altro discorso, ripeto, senza che uno debba escludere l’altro.
Voglio dire, e mi sembra di averlo già detto, che il problema complesso non può essere affrontato da un solo punto di vista, che come sostieni tu dovrebbe essere eminentemente politico, ma può essere anche affrontato individualmente e socialmente con una presa di coscienza a livello sociale, che dovrebbe prevedere un’educazione più diffusa e capillare per mitigare gli aspetti più aggressivi della natura umana. Tutti gli aspetti sono interconnessi tra loro e si condizionano reciprocamente. O no?
A questo punto mi sento autorizzato ad aggiungere al couscous ed al minestrone un po’ di macedonia… e trascrivo qui sotto un brano (estrapolato, e dunque spero comprensibile) da un mio scritto di qualche anno fa (“Uscire dal ghénos”) in cui riporto in estrema sintesi le tesi di Virno su moltitudine, popolo e individuo, a partire dall’interessantissima teoria dell’individuazione di Simondon – tesi nelle quali mi ritrovo pienamente, o che comunque reputo foriere di sviluppi teoretici (e pratici) in grado di andare al di là degli schemi rigidi che oppongono individuo e società:
Virno riprende qui le teorie sull’individuazione di Simondon: l’essere umano è un soggetto anfibio, un misto di indeterminato (preindividuale) e di individuale. Proprio nel rapporto (e nella frizione o crisi) tra questi due elementi della “natura umana” si gioca la partita etico-politica futura. Virno intravvede nella moltitudine non tanto un bene in sé, quanto la possibilità di conferimento del massimo valore all’individuo sociale, all’esistenza irripetibile del singolo già sempre correlato, in rete con i suoi simili, senza la forzatura di dover aderire a un universale posticcio e imposto dall’alto, un universale che sarebbe una reductio ad unum delle sue molteplici possibilità – che dunque pretende di assimilare a sé il singolo, un ghénos che riassorbe in sé l’individuo atomizzato. In ciò riprende l’idea, spesso trascurata in Marx, del collettivo come potenziamento dell’individuale: proprio gli elementi indeterminati di cui ogni individuo determinato partecipa possono tradursi in una ulteriore individuazione resa possibile e anzi sollecitata dalla dimensione collettiva. Ciò significa che la moltitudine non coincide con una forma di anarchismo e che intende piuttosto coniugare in maniera creativa e dinamica, l’individuale e il collettivo, ponendosi al di fuori della logica identitaria del ghénos e della guerra che essa comporta.
Ciò che secondo Virno rende epocale ed ineludibile il nodo della “natura umana” è l’attuale fase del capitalismo avanzato, che mette al lavoro, e dunque irretisce nella logica dello sfruttamento e della valorizzazione, proprio quell’invariante biologico, in particolare la facoltà creativa del linguaggio, che fino ad ora era rimasto inespresso e sottotraccia, e su cui si gioca il destino politico della moltitudine.
@Vincenzo:
“la società fonda l’individuo”
Su questo punto, diversamente da te, non mi accontento di prenderne atto, ma critico il modo in cui eventualmente la società fonda l’individuo, cercando di scoprire l’origine dei processi evolutivi che ci hanno fatti diventare e essere ciò che siamo. Perché solo se capisci gli automatismi che ci muovono come burattini, puoi avere qualche possibilità di evitare di essere biologicamente determinato. Per questo mi chiedo se non si può far qualcosa per fare in modo che l’individuo possa essere “fondato” in altro modo. Andare alla radice del problema, quindi, e non soltanto potare le fronde.
Come Foucault puntualizzava, non voglio limitarmi a dire “così stanno le cose”, ma lo dirlo nella misura in cui si possa trasformare il reale.
Tu dici, attraverso la politica. Mentre a mio avviso la politica è finora e ancora il campo dove si esprimono e si ripropongono le stesse conflittualità e gli stessi comportamenti aggressivi di dominio. Politica come polemos, come guerra diminuita, ma pur sempre guerra. E purtroppo c’è chi la fa, molto più contro di noi che a nostro favore. Il problema della politica è che viene fatta dai politici.
Guarda anche solo questa discussione fra me e te. Stiamo collaborando o siamo entrati in competizione? Ma a che scopo la competizione? Perché? Bisogna aggredire il problema, i problemi comuni, collaborando tra di noi, e non aggredirci tra di noi.
Ad esempio, non ho alcuna ragione di schierarmi dalla parte dei comunitaristi o degli individualisti.
Quindi, leggendo solo adesso il commento di Md., comprendo ancor meglio la necessità di evitare di dare asilo ad una visione oppositiva tra individuo e società.
Ovviamente non conosco a fondo Virno, ma certo l’idea che nella moltitudine inarrestabile possano nascondersi forze ancora inespresse, e quindi la possibilità di “Uscire dal Ghenos” (che andrò a rileggermi), è qualcosa che stava emergendo anche nelle mie riflessioni.
@md: grazie per la macedonia (se non è pretendere troppo, possiamo aspettarci anche il dolce, magari con un tè allo zenzero? ;-))
…prodotti di una società che vorrebbero “sovvertirla”?
Cara Rozmilla, ti ringrazio degli interventi, ma, malgrado i miei massimi sforzi, proprio non riesco a starti dietro, hai scritto tanto.
Credo che, anche per mia colpa, la discussione stia diventando confusa: forse davvero sono entrato in cucina nel momento sbagliato e rischio solo di farvi bruciare il cuscus che così pazientemente stavate preparando. Il danno purtroppo è già stato fatto e proverò a mio modo a mettere ordine nella discussione.
Entrando per l’appunto in cucina, mi è sembrato di sentire una discussione, ma correggimi se sbaglio, che era tutta centrata sul controllo personale dei propri desideri.
Non solo, la discussione era diventata di tipo psicologico, come essere abbastanza forti da imbrigliare i propri desideri da una parte, e come diventare un essere morale dall’altra.
Che si possa privilegiare il livello psicologico, è una cosa che si capisce, purchè non si finisca per ridurre il problema a una questione esclusivamente psicologica, strada che mi pare, ma mi posso sbagliare, lungo cui Carlo e tu stavate per incamminarvi.
Ancora più grave mi pare la questione dell’essere morale: l’uomo è un essere morale, non è che ci sia un’alternativa, è un fatto dato da tutti per scontato. Così, quando qualcuno si comporta male, non è che non sia un essere morale, ha una morale di scarsa qualità, ogni discussione non può che riguardare la qualità della morale, quale morale sia preferibile, non che si debba avere una morale per chi ne fosse privo.
Ora, dando per scontato che i desideri sono parte essenziale della nostra vita, desiderio che finisce con l’identificarsi con la stessa spinta vitale, non dovremmo concludere che non ci sia nulla di male nel desiderare, e che ciò che è sbagliato è pretendere di soddisfare tutti i nostri desideri? Si tratta, mi pare, di due momenti ben distinti, che non dovremmo confondere, non dobbiamo pensare che esistano desideri sbagliati, ma che di sbagliato può esservi solo quello di soddisfarli senza operare una selezione preliminare.
Naturalmente, tale selezione può avvenire solo a livello culturale, sono le convinzioni che ci siamo costruite lungo la nostra vita che ci guidano in questo processo, né può essere diversamente da così. Evocare l’intelletto, mi pare che possa generare solo confusione, l’intelletto è una facoltà, ma quando scegliamo, lo facciamo su contenuti mentali di natura culturale, usiamo l’intelletto, ma l’oggetto concreto sono specifici contenuti mentali, come possiamo bene utilizzare un martello, ma per conficcare dei chiodi, e per quanto di buona qualità sia il martello, potremmo conficcare solo i chiodi che possediamo, ed in alcuni casi questi potrebbero risultare troppo piccoli, o troppo lunghi, la qualità del martello non ci aiuterà a disporre di chiodi più adatti.
I contenuti mentali derivano dalla cultura cioè dalle nostre esperienze, in primis dalla nostra educazione. Ciò che noi siamo, è determinato da dove e da quali genitori nasciamo, e tutto questo non è né bene né male, mentre mi pare che nelle tue parole trasparisse una sorta di sconforto per il condizionamento. Ora, io certamente amo la libertà, ma l’essere storico che io sono non può che essere soggetto alle condizioni concrete della mia vita: in fondo, il modo migliore per essere più libero è tentare di conoscere di più, non è negando l’impossibile, cioè come siamo stati educati e formati, a salvarci dal condizionamento, ma soltanto aprendosi a nuovi contenuti culturali, avere a disposizione un parterre più grande di opzioni da cui scegliere, dando comunque per scontato che un certo grado di condizionamento è inevitabile.
Andiamo adesso alla questione del rapporto tra società ed individuo, perché mi pare che qui, certo per mancanza di sufficiente chiarezza da parte mia, è nato un equivoco anche con Mario. E’ evidente che esistano elementi strettamente individuali in tutti noi, a partire dal carattere: come ognuno di noi ha un certo colore dei capelli, una certa altezza, certe determinate caratteristiche fisiche, è ovvio convenire che avremo anche certe determinate caratteristiche psicologiche, due differenti persone rispondono così in maniera differente alla stessa condizione ambientale. Mi dispiace di non averlo chiarito prima, ma lo davo per ovvio.
Sorvolavo su questo aspetto perché non mi pare così rilevante. Se un dietista deve curare gli alunni di una certa scuola, non starà lì a specificare che i risultati della dieta non saranno uguali per tutti, questo è noto, ma tenterà di mettere in condizione i ragazzi di ottenere uno sviluppo fisico quanto migliore possibile: che importanza mai avrà se uno rimane più basso ed un altro raggiunge magari i due metri?
Tornando a noi, il pensiero liberale pensa che gli uomini siano esseri liberi e razionali, e da questo fa discendere che basti rimuovere alcuni elementi che frenano questo sviluppo pieno della nostra individualità, e l’umanità raggiungerà la felicità di tutti.
E’ questo che io contesto, l’uomo non è né libero né razionale. Non è libero perché è anche un essere sociale, e le società si sono costituite proprio perché la natura stessa dell’uomo l’ha consentito. Non è razionale perché oltre la razionalità, operano altre forze di natura emozionale che condizionano i nostri comportamenti (e meno male, pensa che noia una vita trascorsa in modo ferreamente razionale…).
In ogni caso, la società viene prima, almeno cronologicamente la cultura con cui saremo tirati su dalle nostre madri ci preesiste, e parlare quindi di un uomo come un individuo è già un errore, l’individuo in termini rigorosi non esiste, ciò che siamo, la stessa cultura che ci aiuta ad essere più liberi ce l’hanno data dall’esterno, tutte le stesse armi che possiamo adoperare per difendere ed ampliare la nostra libertà provengono da uno specifico contesto storico che naturalmente nessuno di noi ha scelto.
Scusate la lunghezza, ma non è che voi siate da meno di me come lunghezza degli interventi…
Spero almeno che adesso mi sia espresso in maniera più chiara. Scusatemi se non dovessi intervenire ma lo farà solo se ci sarà speranza di diventare ancora più chiaro.
Wow, Vincé …. è vero che me scrive sempre commenti esagerati, ma il tuo è il più lungo in assoluto. Lo leggerò dopo cena; ora devo andare a cucinare: lenticchie e riso questa sera.
ciao 😀
Rilassati, Vincè, non c’è alcun danno. Non è questo che intendevo, il couscous e il minestrone erano solo una metafora, nemmeno riuscitissima. Va tutto bene.
Che l’uomo sia un essere morale, secondo me “si dice” che l’uomo sia un essere morale, perché la qualità della morale comporta l’essere morale o meno. Wittgenstein faceva un esempio dei concetti che usiamo: diceva che essi sono come un regolo, per cui, se prendiamo il concetto di “morale”, la morale di un tipo è una certa tacca del regolo, un’altra morale un’altra tacca del regolo. Quindi, anche Hitler (è un esempio) aveva una morale, ma nessuno riuscirebbe a dire che la morale di Hitler fosse giustificabile. Perché la morale si giudica (anche) dalle conseguenze delle azioni, da ciò che produce. Quindi la si giudica a posteriori purtroppo, se non azzecchiamo la morale “giusta” a priori.
Che le distinzioni fra i desideri che posso seguire o meno avvengano solo a livello culturale, allora non sarebbe possibile alcun cambiamento, perché saremmo culturalmente (oltre che biologicamente) determinati. E quindi saremmo fermi all’età della pietra o nemmeno, perché non ci sarebbe stata alcuna evoluzione. Ma poiché sostengo che persino su molti aspetti del bios non siano totalmente determinati, figurati se accetto che lo siamo culturalmente. So che non sono facili da forzare, ma bisogna sforzarsi. Alltrimenti che si vive affa’?
Me, “io” come soggetto individuale e individuato (e conseguentemente le collettività) posso scegliere, tra le plurime opzioni che mi sono culturalmente offerte (e in questo momento storico sono davvero molte numerose), quali corrispondono (in primis) maggiormente al mio/nostro personale sentire, oltre che … eccetera.
Il mio essere storico è soggetto alla cultura del mio tempo e del mio essere ciò che sono per nascita educazione eccetera, ma solo relativamente, altrimenti non esisterebbe alcuno spazio di libertà, e saremmo totalmente determinati, vale a dire culturalmente trincerati. Non lo siamo.
Se tu credi di non esistere come individuo, mi dispiace per te. Probabilmente non avremo modo di mangiare insieme. Sto scherzando.
Comunque la cosa che mi fa infuriare dei deterministi, è che con la scusa del determinismo possono riuscire ad assolvere la loro coscienza. Perché tanto siamo fatti così e non ci possiamo fare niente. La colpa è della storia, della cultura, della società e del pene di mio nonno.
In realtà credo che in gran parte si tratti di un carenza epistemologica. È per questo che non sono l’unica a credere che una corretta educazione, e l’allargamento dei propri orizzonti, potrebbero cambiare molte cose. Anche se è chiaro che questo deve essere fatto, messo in pratica. Anche se, ad ogni modo, ogni azione che si compie, ogni parola che ognuno di noi esprime, è già azione politica: costruisce il mondo in cui viviamo, di giorno in giorno.
«Si potrebbe fissare il prezzo dei pensieri. Alcuni costano molto, altri poco. E con cosa si pagano i pensieri? Io credo così: con il coraggio.»
[Ludwig Wittgenstein]
Scusa Rozmilla, ma dove hai letto questo determinismo in quello che ho scritto? Ma se avevo pure fatto l’esempio delle brioscine della Barilla? Che c’entrava con il determinismo? Se poi aggiungo che quel che uno è dipende in maniera determinante da dove nasciamo, ciò non implica che esistano situazioni culturali differenziate?
Io tentavo di dire una cosa differente, ma non avrò il dono di farmi comprendere, dicevo che ognuno di noi influenza gli altri col proprio comportamento e che quindi a rigore non esiste alcuno spazio esclusivamente privato, ma la chiudo qui perchè non ci si intende neanche un poco.
Beh, lo hai scritto tu, il commento precedente, non io. Ti riporto le affermazioni in cui scrivi che siamo determinati, non liberi eccetera, anche se complessivamente tutto il tuo discorso tende verso il determinismo, anche se dici di amare la libertà.
“Ciò che noi siamo, è determinato da dove e da quali genitori nasciamo, e tutto questo non è né bene né male, mentre mi pare che nelle tue parole trasparisse una sorta di sconforto per il condizionamento”.
“l’essere storico che io sono non può che essere soggetto alle condizioni concrete della mia vita”: soggetto o assoggettato?
“l’uomo non è né libero né razionale”, eccetera.
“la cultura con cui saremo tirati su dalle nostre madri ci preesiste”, eccetera.
“le stesse armi che possiamo adoperare per difendere ed ampliare la nostra libertà provengono da uno specifico contesto storico che naturalmente nessuno di noi ha scelto”.
E anche nel tuo ultimo commento:
“Se poi aggiungo che quel che uno è dipende in maniera determinante da dove nasciamo, ciò non implica che esistano situazioni culturali differenziate?”
Appunto, ripeti ancora che “quel che uno è dipende in maniera determinante da dove nasciamo” – e se anche esistono situazioni culturali differenziate, ognuna di esse è pur sempre determinante?
Dimmi tu se questo non è determinismo.
Magari non te ne accorgi nemmeno, oppure devi lavorarci ancora un po’ su queste questioni.
Ma se può consolarti, è ovvio che non credo neppure possibile una totale indeterminazione. Ci mancherebbe. Dico solo che se non potessimo forzare le condizioni date, alcune condizioni date, non sarebbe stata possibile nemmeno alcuna evoluzione, e nessun cambiamento futuro che non sia totalmente determinato dalle condizioni date.
Se non crediamo possibile di poter cambiare, come potremmo cambiare secondo i nostri desideri e la morale, come espressione della nostra libertà di scelta?
Potremmo solo cambiare secondo il destino già predeterminato dalle condizioni di partenza.
Il che in parte è anche vero, che esistano delle condizioni di partenza in cui già in potenza sono inscritte varie possibilità: ma “varie possibilità”, non solo una. Ed è in questo strettissimo spazio, nella crepa del granitico essere ciò che siamo, che esiste la possibilità di scegliere ciò che potremmo diventare. Ciò che ancora non è.
E comunque ti assicuro che questi non sono “miei” pensieri, ma elaborazioni di pensieri di altri che hanno appreso pensieri di altri eccetera. A differenza di quanto tu affermi, io affermo di esistere come individuo, così come sono, solo perché integrato in una collettività. Questo però non mi deve levare il mio status di uomo, quindi di individuo. La collettività non esisterebbe senza gli individui che contribuiscono alla collettività.
Mi spiace che vuoi chiudere qui, dicendo che non ci s’intende neanche un poco. Ci sarà modo di intenderci, dico io, magari più in là o su altre questioni. Ciao.
tra l’altro tutta questa riflessione su determinismo/indeterminazione – ma proprio tutta-tutta, dalla a alla z – è presente in Marx (anzi è forse il centro vero del suo pensiero), un Marx che infatti oggi viene letto più dagli economisti e dai capitalisti e dai liberisti, che non dall’area critica o antagonista, come – ahimé – sempre avviene nella storia; che non significa che occorra scimmiottare Marx, ma semplicemente che le questioni sono ancora quelle, tutte lì, aperte e squadernate dinnanzi a noi…
Vedi Rozmilla, prendere atto che certe cause determinino certi effetti non significa essere deterministi, e trovo stravagante che non cogli la differenza. Sennò dovremmo arrivare alla conclusione che se dico che la pioggia determina il fatto che mi bagno se mi trovo all’aperto significa che sono un determinista.
In ogni caso, in filosofia, i deterministi sono altri, è uno specifico tipo di filosofia che dice tutt’altro, è una cosa ben nota.
E’ per me comunque una autentica sorpresa constatare quanto molti attorno a me siano così affezionati all’idea di scegliere liberamente le proprie vite da chiudere gli occhi di fronte alla realtà.
Chi parla in italiano? Quelli che nascono in Italia (ed in canton ticino)..che strana coincidenza.
Chi è che è musulmano? Quelli che nascono nei paesi musulmani, che coincidenza.
Chi mangia la pasta? Non saranno gli italiani che hanno una tradizione culinaria di questo tipo, che coincidenza…
Devo ancora andare avanti? Noi controlliamo i dettagli, ma è la società in cui viviamo che determina o quantomeno influenza profondamente i nostri comportamenti, basta non essere ciechi per accorgersene. Per questo, parlaare di libertà sconfina quasi sempre in una vuota retorica della libertà.
Ma anche se una specifica persona riuscisse ad essere straordinariamente libera, avrebbe comunque il dovere di considerare i molto più numerosi casi di gente, di nostri simili, che non hanno avuto la fortuna per i motivi più svariati di uscire dai condizionamenti sociali, che non sono una mia invenzione, stanne certa.
Questa discussione non costituisce per me una elucubrazione fine a sè stessa, al contrario è la base che mi spinge a lottare contro il pensiero unico liberale, ma queste cose le ho già detto precedentemente, ed è ora di fermarmi qui.
…Nietzsche scopre Spinoza(30 luglio 1881)
“…ed ecco che non solo la tendenza generale della sua filosofia è identica alla mia: -fare dell’intelletto la passione più poderosa; ma mi ritrovo ancora in cinque punti capitali della sua dottrina; questo pensatore, il più abnorme e solitario, mi è vicino in sommo grado appunto in queste cinque argomentazioni: egli nega il libero arbitrio, :le cause finali;l’assetto morale del mondo; il disinteresse; il male”
“prendere atto che certe cause determinino certi effetti non significa essere deterministi”
Idem: prendere atto che esista uno spazio di libertà non significa essere liberisti, e trovo molto stravagante che non tu non colga la differenza. Visto che ti basta che qualcuno parli di libertà ed individuo, per mettergli l’etichetta di liberista, se non persino magari allineato col pensiero unico.
E comunque ho già scritto nel precedente commento cosa ne penso del rapporto determinismo/indeterminismo. Potrei scriverlo in molti altri modi, ma basterebbe che tu rileggessi quanto ho già scritto in proposito, a meno che tu sia così determinato da non riuscire a vedere la differenza fra ciò che c’è scritto e ciò che credi che ci sia scritto. O che vuoi credere che io creda o sostenga.
La “vuota retorica sulla libertà”, potrebbe essere una vuota retorica, quando lo è; mentre come la intendo io non è affatto vuota retorica.
La libertà è in diretto rapporto con il problema del dovere morale – e il male – e la possibilità di poter adempiere ai propri doveri morali – in opposizione al male. Tra l’altro. Quindi non è da intendere come la “libertà di fare il cazzo che mi pare”, come magari vorrebbero certi liberisti. (Come vedi, la mia posizione è diametralmente opposta a quella di quel tipo di liberisti.
Ma anche i liberisti non sono tutti uguali, e dal punto di vista politico può rivelarsi più interessante scoprire i punti in comune, ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide.)
Quindi, se noi pensiamo l’uomo come essenzialmente e totalmente determinato dalle condizioni date, allora non ha mai alcuna responsabilità nemmeno rispetto alle azioni che compie, perché non avrebbe potuto fare le cose diversamente da come le fa fatte, come le fa, e come le farà.
Un esempio, un tipico caso di femminicidio come oggi ne accadono spesso: un uomo uccide una donna perché quella donna non accetta di essere sottomessa. Secondo la teoria dei deterministi, quell’uomo non avrebbe nessuna colpa né responsabilità per la sua azione, perché l’educazione che ha ricevuto e la società in cui è vissuto lo hanno formato in modo tale da non poter fare diversamente.
Ma, a questo punto io dico che anche il determinismo è una colpa, nel senso ha la responsabilità di infondere negli uomini, e nella società, l’idea che siamo determinati e quindi in definitiva non responsabili delle nostre azioni.
Certo, l’ignoranza e la stupidità esistono, ma sia individualmente che collettivamente abbiamo il dover morale di sconfiggere l’ignoranza e il male. Secondo me, il determinismo è parte di quel male, perché è la fede che l’uomo non sia responsabile delle sue azioni e padrone di se stesso. Il determinismo è il postulato che rende schiavi per fede e partito preso.
E ad ogni modo, non trovo molto utile affrontare le questioni mettendo in evidenza, se non addirittura sottolineando o ingigantendo arbitrariamente gli aspetti che possono sembrare in contrasto, e dividerci; quando invece troverei più proficuo partire dagli aspetti che abbiamo in comune e che possiamo senza dubbi condividere.
Ad esempio, condivido quando parli delle brioches del sig. Barilla, e certamente molte altre cose.
Mentre, quando andiamo a vagliare aspetti e concetti più complessi, molto dipende da quello che abbiamo studiato-appreso-compreso-elaborato in proposito.
@filosofiazzero: nemmeno Nietzsche le ha sempre azzeccate tutte – sai? Anche lui aveva interesse di cogliere solo quello che aveva interesse di cogliere, anche da Spinoza.
Per Spinoza, per quanto sia sovrana la catena della necessità – ma dove il causale non è casuale, come in Nietzsche – il secondo tipo di conoscenza, lo scire per causas (la ragione) ci permette di essere liberi. Poiché la libertà non è data dall’assenza di vincoli, ma dalla cognizione adeguata di essi.
Infatti, se siamo inevitabilmente momento di una catena causale, è anche vero che siamo a nostra volta causa e perciò siamo in condizione di modificare la nostra condizione con una sorta di feedback, con una ripresa in avanti di ciò che ci determina, un riassetto della nostra potenza nella direzione della sua espansione.
Servo è chi ignora la necessità pretendendo d’essere sciolto da ogni legame, condizione; libero è invece chi determina la sua condotta nella conoscenza dei vincoli a partire dai quali si governa e governa.
(tratto dall’introduzione di Salvatore Natoli, all’Etica di Spinoza)
Rozmilla:
…Le considerazioni di Nietzsche che diligentemente ho ricopiato potrebbero almeno servire come aiuto per l’aggiustamento dell’idea che noi si potrebbe avere del pensiero di Spinoza. Almeno io credo!
in effetti la questione determinismo/necessità/libertà (e antifinalismo) è controversa – e però essenziale – nel pensiero di Spinoza; banalizzo: è sufficiente avere piena coscienza delle determinazioni e della causalità di cui si è parte per definirsi “liberi”? Spinoza sostiene chiaramente che noi non si è “liberi”, ma nemmeno sostiene che si è fatalmente necessitati. E d’altra parte credo che non ci sia concetto più imprendibile ed inafferrabile (e però necessario) di quello di “libertà”.
Tanto per cambiare avete aperto, allargato (e complicato) la discussione…
@filosofiazzero:
le considerazioni di Natoli che diligentemente ho ricopiato, potrebbero servire come aiuto per l’aggiustamento dell’idea che noi si potrebbe avere del pensiero di Spinoza, come viene interpretato da Nietzsche.
Rozmilla:
…giustissimo quello che dici, poi naturalmente (o anche no) ognuno ci avrà la sua idea su uno Spinoza più i meno addomesticato e utilizzabile dal pensiero “buono”.
…le parole di Natoli mi fanno (almeno mi sembra a me) subito pensare a un discorso di Bersani o del nostro benemerito presidente Napolitano
@filosofiazzero: rispondo solo al tuo commento precedente.
“ognuno ci avrà la sua idea su uno Spinoza più i meno addomesticato e utilizzabile dal pensiero “buono””
Certo, ma se siamo persino in grado di scegliere fra una interpretazione e l’altra, qualcosa vorrà dire, o no? Rispetto alla libertà di scegliere una o l’altra cosa.
Per esempio, l’interpretazione di Nietzsche che dice che per Spinoza non esiste il male, trovo molto difficile da sostenere.
“Spinoza intende per bene ciò che sappiamo con certezza d’esserci utile, e male ciò che ci danneggia. E il massimo utile per l’uomo è la concordia, che non è il banale volersi bene.
“Il bene che l’uomo appetisce per sé, e che ama, lo amerà più costantemente se vedrà che anche altri lo amano; e perciò cercherà di farlo amare anche agli altri: e dato che questo bene è comune a tutti, e di esso tutti possono godere, si sforzerà allora perché ne godano tutti, e tanto più quanto più godrà di questo bene” [Etica IV, prop. 37]
Per questo l’odio – e Spinoza precisa, l’odio verso gli uomini – è sempre male. E lo è anche perché l’odio accresce sempre di più l’odio, non si spegne e distrugge.
Chi combatte l’odio con l’amore alla lunga lo vince, perché “combatte lieto e sicuro (secure pugnat) …”. L’odio scaturisce da un difetto di ragione: gli uomini si odiano perché non capiscono. Ma vivere secondo ragione significa valorizzare ciò che è comune.” [sempre tratto dall’introduzione di Natoli]
Ovviamente ciò che è comune potrebbe essere anche qualcosa di spiacevole da scoprire, nel caso si trattasse di odio, violenza e crudeltà. Stupidità e ignoranza. Ma è meglio scoprirlo prima che dopo.
@Md: dipende da cosa crediamo o “pretendiamo” dal concetto di libertà.
Per come la vedo io, si son fatti fin troppi voli pindarici su questa idea, immaginandosi tutto e di più e l’impossibile.
E allora è chiaro che ci si guarda allo specchio e si dice: eh, ma allora io non sono libero. Ma libero de che? Cosa pretendiamo da questa illusoria idea di libertà?
La mia idea di libertà è molto basica. Quando ho eliminato tutte le illusioni che potevo essermi fatta sulla “mia” libertà, quello che rimane è il nocciolo della libertà. E saremmo degli uomini ben miseri se non avessimo, o non riscoprissimo in noi questo nocciolo.
“Gli uomini si ingannano nel credersi liberi; e tale opinione consiste solo in questo, che, essi sono consapevoli delle loro azioni e ignari delle cause da cui sono determinati”
Etica . parte seconda, proposizione XXXV, Scolio.
@Filosofiazzero:
Non conosco l’Etica a menadito, e non ho trovato la proposizione che citi. Forse non hai indicato il numero giusto, ma mi pare strano che un’edizione diversa riporti un numero diverso.
Comunque, per quanto gli uomini s’ingannerebbero a credersi liberi, possono essere liberi quando sono guidati dalla ragione.
La cosa che trovo interessante è che si ha l’impressione che Spinoza stesso si ritenesse un uomo libero, anche perché parla di “uomini liberi” in varie preposizioni. E non avrebbe potuto parlare di qualcosa che non esisteva, e che non conosceva.
«Ho detto che è libero chi è guidato dalla sola ragione.» [Etica IV, prop. 68 dim.]
«[…] dall’idea di Dio, dal quale soltanto dipende che l’uomo sia libero, e che il bene che egli desidera per sé, lo desideri anche per gli altri uomini ….» [Etica IV, prop. 68, scolio]
«La virtù dell’uomo libero si mostra egualmente grande nell’evitare come nell’affrontare i pericoli.» [Etica IV, prop. 69]
«L’uomo libero che vive fra ignoranti, si studia quanto può di evitare i loro benefici.» [Etica IV, prop. 70]
«Solo gli uomini liberi sono massimamente grati gli uni agli altri.» [Etica IV, prop. 71]
«L’uomo libero non agisce mai con frode, ma con onestà.» [Etica IV, prop. 72]
«L’uomo che è guidato dalla ragione è più libero nello Stato, dove vive secondo una decisione comune, che in solitudine, dove obbedisce soltanto a se stesso. » [Etica IV, prop. 73]
«L’uomo libero non pensa a niente meno che alla morte; e la sua sapienza è meditazione non della morte ma della vita.» [Etica IV, prop. 67]
Come abbiamo visto in primo luogo per Spinoza la libertà consiste nella libertà “di” emendare l’intelletto.
In secondo luogo, per Spinoza la libertà è libertà di essere liberi “da” …
L’ultima parte dell’Etica, la quinta, riguarda la via che conduce alla libertà.
E questa è l’ultima preposizione:
« La beatitudine non è premio alla virtù, ma è la virtù stessa; e noi non godiamo di essa perché reprimiamo le libidini, ma, al contrario, proprio perché godiamo di essa, possiamo frenare le libidini.» [Etica V, prop. 42]
[tratto dall’Etica di Bento Spinoza, Universale Bollati Boringhieri (2009)]
…qund’è così chiudo il becco!
Bisognerebbe invece considerare come mai per alcuni (per esempio marxisti)in Spinoza c’è la libertà, e in altri, (per esempio scettici) la libertà (in senso assoluto)non c’è.
La mia citazione dalla parte seconda De Mente XXXV, Scolio, pag 185, Sansoni Firenze 1984
…però mi viene un dubbio: che la tua sia un’edizione “purgata”?
Rozmilla, il problema che abbiamo è essenzialmente di comunicazione, tu mi attribuisci alcune idee che io neanche mi sogno di avere e pretendi perfino che io abbia attribuito a te stessa delle idee, che io neanche penso.
Cominciamo da qui: dove ti avrei data della liberista? Ma stiamo scherzando, non è che ci si conosca, ma è evidente anche a un lettore distratto che tu sei anni luce distante dal liberismo, quale improvviso demone ha invaso la tua mente facendoti credere ciò? Certo che se tu mi attribuisci pensieri che io non ho mai espresso, la comunicazione diventa difficoltosa se non del tutto impossibile.
Torniamo ora brevemente al determinismo. In filosofia il determinismo è di tipo ontologico, e non c’entra nulla con le argomentazioni che tentavo di esporre io.
Sulle cose che dico, non capisco come si possano sollevare obiezioni, si tratta di fatti statistici verificabili da parte di tutti.
Se li metto così in evidenza, non è per tentare di spingere a comportamenti fatalistici, ma al contrario, per sostenere l’impegno nel sociale, nell’aumentare il nostro grado di cittadinanza, nel non credere che possiamo salvare noi stessi fregandocene di chi ci sta intorno.
Da ormai diciotto anni, mi sono trovato a tracciare un percorso di pensiero solitario, che cioè non trova in quanto già elaborato da altri risposte soddisfacenti alle domande che come ogni altro uomo mi pongo.
E’ vero che mi capita a volte di scoprire l’acqua calda, cioè riscoprire indipendentemente cose che altri hanno già elaborato e che io colpevolmente ignoravo, e complessivamente questa solitudine in cui percorro questi sentieri di pensiero tra gli altri inconvenienti ha quello di dovermi occupare di discipline diversissime, ed insomma è vero che c’è nel mio pensiero un grado piuttosto elevato di dispersione.
Malgrado questi difetti, un’erudizione insufficiente che mi conferisce un certo grado di dilettantismo e una tendenza a disperdermi tra filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, economia e politica (ma avrò certo dimenticato qualche altra disciplina) , sono tuttavia convinto di avere trovato nel liberalismo in senso lato, e quindi anche nell’illuminismo, ed anche nel pensiero occidentale a partire dallo stesso Platone la fonte dei guai in cui trovo che si sia cacciata l’umanità, e che qualunque forma più o meno vaga di speranza di uscirne fuori è quella di battere questo pensiero unico che ci avvolge tutti.
Ormai, quel primo libro che ho scritto costituisce per me una specie di base di partenza, ma capisco di doverne scrivere uno nuovo che riesca a mettere meglio a fuoco i punti decisivi delle mie critiche e proposte.
Ti ringrazio quindi delle tue obiezioni che possono solo servirmi ad affinare sia le teorie in quanto tali che il modo di esporle: purchè naturalmente, mi si legga per quello che scrivo e non attribuendomi cose che non dico, magari sulla base della propria formazione culturale.
@Vincenzo: scusa la franchezza, ma le generalizzazioni su liberalismo, illuminismo, platonismo (il pensiero occidentale come fonte di tutti i guai del pianeta, ecc.), assomigliano molto a quelle che tanto sembri criticare – su tutte lo stile di pensiero di Emanuele Severino, che però, per lo meno, ha costruito solide (anche se non certo inoppugnabili, come lui pretenderebbe) argomentazioni in proposito.
Quando cominciai a leggere il tuo libro “L’ideologia verde”, ebbi esattamente questa impressione, e ad esser sincero fu ciò che mi impedì di completarne la lettura.
credo che la questione della libertà in Spinoza sia aperta e controversa; io, a suo tempo, quando mi immersi nella lettura dell’Etica e tentai di ricavarne delle “lezioni”, giunsi a questa interpretazione:
“Un affetto, che è una passione, cessa di essere passione non appena ce ne formiamo un’idea chiara e distinta”.
La passività si dissolve (o si riduce) attraverso la potenza (cioè il grado, la facoltà) conoscitiva. Poiché ogni affezione è conoscibile in modo chiaro e distinto, ci è data la possibilità – nella misura di questa stessa chiarificazione e distinzione – di non esservi supinamente soggetti. Ma non basta: la conoscenza adeguata è quella che considera come necessarie tutte le cose (“in quanto comprendiamo, possiamo desiderare solo ciò che è necessario” – aveva scritto verso il termine della quarta parte, ribadendo una concezione che attraversa tutta l’Etica), e solo così il nostro potere sugli affetti potrà estendersi ulteriormente. Non mi basta cioè sapere come sono fatto, da quali affezioni sono mosso, ma devo anche comprenderne la determinazione causale necessaria per potermi definire davvero libero. Sembra quasi un paradosso, un rovesciamento dell’ovvio: ma per Spinoza, poiché la libertà così come di solito viene intesa è pura illusione, solo la comprensione profonda della dinamica necessitante delle cose può aprire la via alla vera libertà, che non può non coincidere con la verità. Solo laddove sapere, potere e dovere si sovrappongono ci può essere libertà, e solo a questo livello comprendiamo la coimplicazione del versante ontologico e di quello etico.
…in pratica, più noi si fosse buoni, meno male ci sarebbe al mondo (escludendo malattie, terremoti etc.)
Ecco, così potrebbe andare bene?
@ filosofiazzero: avevo sbagliato, mi ero soffermata sulla preposizione, senza leggere lo scolio.
comunque non mettevo in dubbio che ci fosse: ero io che non la trovavo …
ora l’ho trovata: m’è bastato voltare la pagina 🙂
però non vedo come la libertà, come qualsiasi concetto possa essere assoluta.
la libertà è sempre relativa a un oggetto esterno o interno, e collettivamente può assumere una forma storicamente determinata (ideale);
e può essere libertà di (per accrescimento della potenza di sé) o libertà da (diminuzione della potenza degli effetti agenti – interni o esterni).
@Vincenzo: in effetti abbiamo fatto un po’ di confusione. Capita. Che ne dici se proseguiamo e andiamo oltre?
@Md:
“ …laddove sapere, potere e dovere si sovrappongono ci può essere libertà, e solo a questo livello comprendiamo la coimplicazione del versante ontologico e di quello etico”
Bello, e concordo in pieno.
Desidero aggiungere alcune considerazioni sul rapporto della libertà con l’alterità. Vale a dire dell’obbligo che abbiamo verso gli altri esseri umani – ma anche verso gli animali – e cioè di considerarli esseri potenzialmente liberi: un obbligo dal quale non possiamo esonerarci senza correre il rischio di diventare dei bruti. Come d’altra parte gli altri esseri umani hanno lo stesso obbligo verso di noi. Senza però trascurare gli obblighi che ognuno di noi ha anche verso se stesso. (Simone Weil)
In pratica, questo vuol dire che non posso trattare gli altri, esseri umani e animali, come se non fossero liberi e portatori di diritti. Idem, gli altri esseri umani non possono trattare me come se non fossi libero e portatore di diritti. (idem, non posso nemmeno trattare me stesso come se non fossi potenzialmente libero e portatore di diritti. E doveri …)
Potenzialmente liberi, però non significa che tutti gli esseri umani lo siano realmente e in atto, né che lo siano sempre né ancora (e da ciò deriva l’obbligo morale di impegnarsi o fare in modo che tutti lo possano diventare.) poiché la libertà implica la possibilità di scegliere e compiere sia il bene che il male. Che difatti già la “possibilità” implica “tutte” le possibilità, non solo quelle che potremmo ritenere preferibili.
Una proposizione di Spinoza, che finora ho omesso, dice:
«Se gli uomini fossero liberi, non si formerebbero nessun concetto di bene e di male, finché fossero liberi. »[Etica IV, prop. 68]
Ed è vero. Un uomo non è libero fintantoché non diventa libero: ossia finché il bene che egli desidera per sé, [non] lo desideri anche per gli altri uomini ….[idem, dimostrazione]
Come anche in Kant, non c’è alcuna libertà nello scegliere il male. «Il buono è l’oggetto della volontà – vale a dire di una facoltà di desiderare determinata dalla ragione.» [Kant, Critica del giudizio].
Per quanto a noi uomini postmoderni relativizzati possa apparire paradossale, la libertà si realizza soltanto nello scegliere il bene.
…appunto dicevo!!!!
….e bisogna che, il bene, lo scelgano tutti, o i più possibile, e che sia il bene riconosciuto da tutti, o dai più possibile, e il più presto, anche, direi, possibile, etc.etc…..
“…donde si può vedere che la legge che proibisce di ammazzare gli animali è fondata piuttosto sopra una vana superstizione e una femminea compassione anziché sulla sana ragione. Il dettame della ragione di ricercare il nostro utile prescrive, bensì di stringere rapporti di amicizia con gli uomini, ma non coi bruti e con le cose la cui natura è diversa dalla natura umana[…]anzi, poiché il diritto di ciascuno è definito dalla virtù e potenza di ciascuno, gli uomini hanno sui bruti un diritto di gran lunga maggiore che i bruti sugli uomini. E tuttavia io non nego che i bruti sentano; ma nego che per questa ragione non sia lecito provvedere alla nostra utilità e servirci di loro a nostro piacere e trattarli come meglio ci conviene…” Spinoza Etica, IV, XXXVII, Scolio I
@filosofiazzero
Il problema è che gli uomini confondono il bene, col proprio utile, il proprio interesse, e lo vogliono tutto e solo per sé. Insomma, non arrivano ancora a desiderarlo anche per tutti gli altri uomini – come dice Spinoza – né per gli altri animali.
Da una parte c’è anche da dire che il bene non può essere imposto, ma solo scelto.
Quindi, di fronte ad un bruto, servirebbe a qualcosa imporre il bene con la forza?
T’immagini un bene imposto con la forza? Non sarebbe più un bene …
Certo che di fronte ad un bruto siamo costretti a difenderci, o cercare di opporre alla forza bruta una forza adeguata per arginare la violenza. Quindi la brutalità costringe anche coloro che magari potrebbero essere naturalmente buoni, ad usare violenza per difendersi per non soccombere alla forza bruta. Se non vogliono essere annientati.
Mentre sul discorso “animali” – quello che citi è un passo che avevo scorso ieri sera – credo che su questo punto Spinoza non avesse ancora sviluppato una sensibilità in proposito.
Spinoza ha pensato e scritto molte cose interessanti, ma sul discorso “animali”, noi oggi potremmo tranquillamente ammettere che era ancora carente.
.Rozmilla:
..di nessun pensatore antico (e moderno)ha senso dire che è o era carente: è solo quello che è o era.
(ammettendo si riescisse a capire quello che è o era)
(non sarebbe la prima volta che succedesse di vedere (o di credere di vedere)un “bene” imposto con la forza!
Bene, Mario, io non ho ripreso per delicatezza l’argomento, ma visto che lo richiami tu, allora lo affronto anch’io, non posso evitarlo.
Dunque, ammetterei con me che inviarti a mie spese il testo che ho scritto, è stato un atto di gentilezza e fiducia nei tuoi confronti.
E come definiresti allora l’atteggiamento che hai assunto tu quando, dopo aver rinviato per mesi questa lettura, alla fine mi dici che l’hai preso in mano, ma che non riesci a leggerlo fermandoti a una mia riflessione certamente sintetica ed inevitabilmente approssimata? Sì, stronco secoli di filosofia occidentale di colpo, ma come avrei potuto fare diversamente? Non potevo certo scrivere un compendio di storia della filosofia, anche perchè non ne avrei avuto le competenze, la mia lettura non ha pretese di esaustività, è fin troppo ovvio, guardoallo sviluppo filosofico da un punto di vista molto particolare, quello evidentemente che mi serve per il proseguo del libro.
Naturalmente, è più che lecito da parte tua dissentire ma non mi pare una cosa conseguente, necessitata, smettere di leggerlo del tutto, anche sapendo (bastava giusto legegre l’indice) che quel testo ha la pretesa di spaziare su tante differenti discipline, e quindi un dissenso, una difficoltà sui temi filosofici non portava in alcun modo all’impossibilità di proseguire nella lettura.
Penso che molti, di fronte a un atteggiamento del tipo di quello che tu hai avuto verso di me, lo potrebbero clasificare come una forma di disprezzo, tanto più ingiustificato intanto per il fatto stesso di averti donato sneza che tra noi ci fosse chissà quale conoscenza pregressa. Inoltre, non è che tu sia stao l’unico ad averlo avuto per le mani, e le reazioni degli altri sono state molto diverse. I difetti e i limiti del mio libro li conosco bene, ma è un libro che riprota idee originali e ben argomentate, mantenedo una sua scorrevolezza, che ne rende agevole la lettura anche da un lettore non troppo culturalmente attrezzato.
No, tu al primo incontro con un punto che magari ritieni rozzamente errato. il che ci può anche stare, abbandoni il tutto.
Come vedi, in questi anni ho continuato a frequentare il tuo blog senza più richiamare l’episodio, ma ammetterai che richiamarlo qui da parte tua costituisce una grave forma di mancanza di rispetto nei miei confronti, come a dire “stai zitto tu che hai scritto un libro che io giudico una schifezza”.
Visto però che così hai deciso, tra l’altro all’interno di una discussione che avevo proprio qui sul tuo blog, usato quasi come una argomentazione decisiva per zittirmi, allora ti dirò chiaramente che ci sei riuscito, non ci sono più le condizioni perchè io torni ad intervenire qui.
Buona fortuna, chi vuole sa dove trovarmi!
@Vincenzo: evidentemente abbiamo concezioni molto diverse del rispetto… però definire la mia critica, fosse anche una stroncatura, un “atto di disprezzo” nei tuoi confronti, o un volerti “zittire” mi pare davvero eccessivo; d’altra parte il tuo stile qui nel blog è sempre stato ruvido e tranchant (fin dal tuo esordio, con l’averlo subito definito “sedicente”), ma si tratta di stile, e tra l’altro l’ho trovato spesso apprezzabile per la chiarezza e nettezza delle tue posizioni.
D’altra parte quando ci si espone pubblicamente – libri o rete o conferenze che siano – è giusto prendersi le critiche, anche quelle più dure. Critiche che hanno a che fare con l’oggetto, non certo con il soggetto. Io qui, in questi 6 anni, me ne sono prese parecchie, mi pare (talvolta anche di personali), e non mi sono mai sentito offeso o disprezzato o sminuito. Ma, evidentemente, abbiamo sensibilità diverse.
Per quanto concerne l’interruzione della lettura, mi appello alle 10 regole di Pennac, che ho applicato imparzialmente ad autori e testi noti e meno noti. Ad ogni modo il tuo libro è qui tra gli scaffali della biblioteca, e potrà essere letto liberamente da chiunque (me compreso), indipendentemente da ogni giudizio di ordine soggettivo o psicologico.
Buona fortuna anche a te!
(ciò non toglie che sia molto dispiaciuto, e che le mie intenzioni non erano certo quelle di ferirti od offenderti)
Rozmilla:
…tra l’altro (vecchio bisbetico quale sono) avrei specialmente da ridire su “ancora carente” te dici, Spinoza, sul discorso animali.
Come se nel pensiero ci fosse un progresso dal meno al più dal peggio al meglio eccetra…
Come, per esempio, tanti giudicano carente Aristotele sulla non condanna della schiavitù, il quale giudizio non ha senso.
Che noi si abbia i nostri giudizi, e gli altri i suoi!!!
Poi ognuno si regolerà come crede.
@filosofiazzero:
Ah, stavo per risponderti prima, ma mi sono fermata un attimo, neh …
Che sì, hai ragione: ognuno è ciò che è dove è. Giustissimo. Non possiamo giudicare Aristotele o Spinoza coi parametri di quello che riteniamo giusto in questo tempo.
Però ricordo che Kant diceva che una norma morale dovrebbe poter reggere ed essere ritenuta valida (quasi) in ogni luogo e tempo. Quasi, neh … Quindi, non giudichiamo i pensatori, o i filosofi, ma per lo meno possiamo verificare se la morale che sostengono possono essere ritenute valide ancora oggi, o meno.
D’altra parte, devo dire che anch’io mi sento carente. Anzi, più passa il tempo, più mi sento carente, mancante … eccetera. Che non faccio abbastanza, o abbastanza bene,
Ma se mi credessi completa, o perfetta – ci stavo pensando stamattina – sarei una specie di “mostro”. Che anzi mi capita di essere contenta di accorgermi di sbagliare. Se non sbagliassi, qualche volta, qualche volta più, qualche volta meno, potrei diventare arrogante – che già un po’ lo sono, neh – ma potrei diventarlo ancor più di quel che sono. Allora sì che sarebbe brutto brutto.
In fondo, chi ci crediamo di essere? Chi è perfetto?
Mi chiedo se persino Spinoza pensasse a sé come a un essere perfetto.
No, non credo: era abbastanza intelligente per evitare di crederlo.
Quindi, sono d’accordissimo quando Md. dice che le critiche sono sull’oggetto, non sul soggetto.
E l’oggetto, dato che noi si scrive, sono i pensieri, quello che crediamo vero (o verosimile) o falso.
In questi giorni sto leggendo “Il lupo e il filosofo”: splendido libro, denso.
C’è un passo che parla del “dovere epistemico”: “è il dovere di sottoporre le proprie convinzioni a un adeguato esame critico: verificare, cioè, se tali convinzioni sono giustificate dalle prove disponibili e almeno accertare se esistano o no prove che le controbilencino. Oggi abbiamo una scarsa considerazione del dovere epistemico: è accettato in misura talmente limitata che la maggior parte della gente non lo considererebbe neppure come un dovere (e questo, di per sé, è una mancanza di dovere epistemico).”
…Spinoza, Kant, il lupo e il filosofo, il dovere epistemico,
Severino, eccetra, ma allora filosofiazzero zero?
@filosofiazzero:
beh, se ognuno è dove è, filosofiazzero anche è dove è. Se non che, puoi anche cambiare, se ti va. Chessò: filosofiauno, folosofiadue … folosofiacento … folosofiamille … o tremila, eccetera.
Certo è che lo zero, oltre ad essere lo spartiacque fra i numeri positivi e negativi, è qualcosa senza il quale non potrebbe esistere il 10 e i multipli di 10 per qualsiasi numero, volendo. E considerando che il 10 è il numero perfetto (per Pitagora, se non erro), lo zero contribuisce alla perfezione dell’universo numerico, ossia senza lo zero non sarebbe possibile nemmeno la perfezione di Dio (come direbbe Spinoza) seppure considerato come causa sui.
D’altra parte ho qualche sospetto che lo zero in natura non esista nemmeno. Mentre filosofiazzero a quanto pare sì.
(ragazzi: qui sta proprio nevicando. E sta attaccando)
“Non sento che è necessario sapere esattamente quello che sono. L’interesse principale nella vita e nel lavoro è quello di diventare qualcun altro che non erano in inizio.” [ Michel Foucault]
…filosofiazzero come sottomultiplo di se stesso!!!
@Vincenzo:
Non so se stai ancora leggendo questo Blog, ma c’è una cosa che vorrei farti osservare. Ossia, che dopo la tua indomita difesa della convinzione che sia predominante la collettività sull’individuo, al punto che a rigore – come tu stesso hai affermato – a rigore l’individuo non esiste, la tua decisione di non intervenire più in questo Blog, sta a dimostrare proprio quello che hai cercato così strenuamente di negare. Che anche tu sei un individuo, Vincenzo – come tutti noi. Un individuo che può scegliere di dire sì o no, di accettare certe condizioni poste o date da una collettività, oppure, diversamente, di non poterle accettarle.
Quindi, scusami la franchezza (sai che non ho molti peli sulla lingua), ma sono tentata di dire che la tua scelta è stata una scelta individualista, oltre che contraddittoria.
Sai, mi è capitato più di una volta, anche nella vita “reale”, di sentirmi più o meno nel modo come immagino possa sentirti tu ora, ma ogni volta, è stato soltanto quando sono riuscita ad appianare le cose e ricongiungermi alla collettività, che sono stata davvero contenta. Per questo ti auguro anch’io buona fortuna. Perché si può sempre ricominciare, niente ce lo impedisce.
È vero che c’è stata una difficoltà di comunicazione fra di noi, ad esempio. Ma quando mai le interpretazioni possono coincidere alla lettera? Come tu dicevi, dovremmo aver la stessa formazione, e aver letto gli stessi libri, tanto per cominciare, o almeno una buona parte. E ad esempio, per quanto abbiamo probabilmente letto libri diversi, sono anch’io dell’idea che il liberismo che ci ha investito come una marea soprattutto negli ultimi 50 anni, sia uno dei grossi problemi da affrontare. Ma non vorrei allargarmi oltre e dire che i nostri guai partono dall’illuminismo, o da Platone, perché in quel caso sarebbe un problema fin troppo esteso, per cui non vedo più dove voglia andare a parare. Senza contare che invece, a mio avviso, l’illuminismo critico kantiano non è poi così da buttare,anzi. Ma qui, appunto, entriamo troppo nei particolari. Anche se certamente non si può evitare di affrontare il problema ontologico di cosa intendiamo per “uomo”, “individuo”, “collettività”, “comunità”, “Stato”, “libertà”, “morale”, e così via.
Ma devo dirti che ultimamente ho trovato molto ricco e interessante il libro del politologo B.R. Barber (Consumati. Da cittadini a clienti), perché affronta il tema del liberismo, e i vari stadi dell’evoluzione del capitalismo, eccetera. Nel salutarti ti rinnovo i miei auguri affettuosi. Ciao.
Quello che mi sorprende sempre nelle discussioni, è che alla fine si difende esclusivamente il proprio punto di vista, col risultato che i dialoganti iniziali si trasformano in contendenti, difensori acerrimi delle proprie tesi, contro quelle dell’altro. C’è un bisogno psicologico, mi sembra, nonché fisiologico e quindi biologico, che porta ciascuno di noi a difendere a spada tratta il proprio punto di vista, per non incorre nella spiacevole sensazione di sentire andar via un pezzo di sé. Ogni punto di vista infatti è come un mattoncino, che accanto ad altri punti di vista (altri mattoncini) costruisce a poco a poco quell’edificio che possiamo chiamare il sé di una persona. Pertanto è ovvio, che se c’è qualcuno che cerca di incrinare o invalidare la nostra visione delle cose, la risposta è di solito quella di difendere la medesima e passare al contrattacco. Meccanismi che hanno ben poco a che vedere con la ricerca della verità, mi pare, e che anzi sfruttano il pretesto della ricerca del vero per affinare le armi e dare battaglia. Ma è proprio vero che la verità può emergere solo dal conflitto? Davvero non esiste una modalità alternativa? E se provassimo a collaborare invece che farci la guerra? La guerra giova alla verità? La divisione giova alla verità? Non è forse più proficuo, e più piacevole, lavorare insieme, con rispetto, piuttosto che separatamente, con dispetto?
Per altro, non pare anche a voi che l’esclusiva difesa del proprio punto di vista determini normalmente una sorta di sordità, con la conseguenza di non riuscire ad ascoltare ciò che l’altro ha da dirci, eludendo in tal modo la possibilità di cogliere, nelle parole del nostro interlocutore, qualcosa che può aiutarci ad allargare i nostri orizzonti? Per quanto mi riguarda, ad esempio, sono contento di essere riuscito a far fruttare alcune delle riflessioni di Vincenzo Cucinotta sul linguaggio, poiché riconsiderando alcune cose da lui dette, mi sono reso conto che in un mio intervento proprio sul linguaggio avevo troppo focalizzato l’attenzione sull’aspetto comunicativo del medesimo, trascurando il fatto che il linguaggio è anche uno strumento per pensare.
Un caro saluto a tutti,
Francesco
(Se non risponderò subito all’autore di un eventuale commento al mio commento, invito l’autore a non prendersela. Non mi trovo nelle condizioni di poter rispondere immediatamente. Risponderò però in ogni caso, anche se non celermente)
@Francesco: come darti torto?
Però io sono un assertore della conflittualità, non tanto per far emergere la verità, ma per far emergere la poliedricità dell’essere, delle cose, degli umani. Solo da contrasto, la meravigliosa armonia di tutte le cose – cito Eraclito a memoria.
Che vuol dire, appunto, conflitto, non guerra. Un conflitto che genera qualcosa, non votato – come la guerra – alla distruzione.
C’è poi l’elemento psicologico, il narcisismo che affligge la nostra epoca (ma che forse, come anche tu accenni, ha una sua base biologica). Anche qui, sarebbe bello riprendere la distinzione roussoiana tra “amor di sé” e “amor proprio”. Ma tra le parole, le buone intenzioni e la prassi, come si sa…
Vorrei poter dire che è la forma blog ad esacerbare talvolta gli animi (e in parte è così, e poi basta un clic…) – ma se osservo le dinamiche dialogiche “reali” non è che ci si discosti molto.
I bambini no, quelli non sono ancora del tutto afferrati dal vortice dell’autoreferenzialità (pur essendo narcisisti per natura) – sono apertissimi, hanno le “n” possibilità dalla loro, e poi dimenticano velocemente, non covano nulla. Ma poi crescono, si strutturano anche loro, e la loro pelle – che prima traspirava ed era quasi trasparente – diventa una corazza abbrutita dall’ostinazione.
Naturalmente non è sempre così – c’è anche una grandissima varietà nella moltitudine.
Francesco:
…proprio così, a spada tratta, ammettendo, preliminarmente, che flo osse possibile capire quello che uno dice o pensa e lo dice o il dirlo non è il pensarlo inquantochè il pensarlo eectra….
Sembra invece che la crittografia la fa faccia ormai da padrona nella filosofia (cosiddetta) contemporanea, quasi fosse peculiare della profondità (ma che vuol dire profondità?) il parlare oscuro…
Che bello che sei tornato Francesco …
Md. Parla dei conflitti, eh sì, però non è male anche quando non ci sono troppi conflitti. Piuttosto credo che dovremmo ad imparare a gestire i conflitti, che d’altra parte sono inevitabili in qualsiasi comunità di umani. Non so, se qualcuno cerca di convincermi che la sua idea è migliore della mia, posso sì vedere la differenza fra la mia idea e la sua, ma come l’altro non è disposto a permettermi di avere una mia idea, io non sono disposta a farmi annientare l’idea che ho io su una certa cosa. Senza contare che scriverne è sempre così difficile, e se anche i pensieri non sono proprio “profondi” come dice filosofiazzero, sono comunque difficili da descrivere in tutte le sfaccettature.
Si potrebbero dire molte cose, in proposito, ma poco fa ho ritrovato in fb. due frasi che trovo significative. Una di Kafka:
“La verità è ciò che ad ognuno occorre per vivere, ma non si può ricevere né acquistare da nessuno. Ogni uomo deve produrla continuamente dal proprio intimo, altrimenti perisce. È impossibile vivere senza la verità. Può darsi che la verità sia la vita stessa.”
L’altra di Foucault:
“Vorrei dire qualcosa sulla funzione di ogni diagnosi sulla natura del presente. (…)
Qualunque descrizione deve sempre concordare con quelle specie di fratture virtuali che aprono gli spazi di libertà intesi come uno spazio di libertà concreta, cioè di cambiamento possibile”.
E per questa sera vi saluto. Ciao a tutti.
@md:
D’accordo, diciamo allora che sia la conflittualità che il desiderio di concordia fanno parte dell’animo umano. Però io credo che si sia più felici in uno stato di concordia che in uno di discordia. Si lo so, la discordia è cosa diversa dal conflitto, che è diverso dal confronto, che comunque preferisco al conflitto. Perché se il confronto è tra individui appartenenti al medesimo gruppo, diciamo così, il conflitto fa pensare ad un contrasto tra individui appartenenti a gruppi diversi. Ma, da come la vedo io, non ci sono gruppi diversi. C’è un solo grande gruppo di appartenenza, quello umano. Tutte le differenze sono di carattere culturale, ed è sul superamento di tali differenze che bisogna lavorare, perché io credo che sia preferibile andare nella direzione del comprendersi piuttosto che nella direzione opposta. Comprendersi è arricchirsi. Arroccarsi sulle proprie posizioni e guardare il mondo dalla propria torre d’avorio è impoverirsi. Umanamente prima di tutto, e poi anche intellettualmente. I mondi (ogni uomo è un mondo) si debbono incontrare, e dialogare. E se il dialogo assume la forma di una danza, tantomeglio. L’uomo deve riuscire a riconoscersi nel suo simile, deve capire che chi ha di fronte è un essere come lui che come lui ha bisogno di amore e di comprensione. E poi sono fiducioso (ingenuo?!). Sì perché penso che nell’uomo vi siano delle qualità latenti, finora non ancora emerse, che potrebbero davvero trasformare la qualità della vita sulla terra. Perché lo penso? Non so. E’ però una sensazione molto forte..
Giusta la distinzione tra conflitto e guerra. Però il conflitto a cosa mira? A primeggiare anziché a distruggere? E chi primeggia cosa ne fa poi di colui su cui ha primeggiato? Lo deride? Lo schiavizza? Lo considera inferiore? Non lo considera?
Tutte cose che dovremmo chiederci, non trovi?
@filosofiazzero:
Già, il parlare oscuro..
E’ vero, per alcun filosofi sembra ci sia una diretta corrispondenza tra il parlare oscuro e la profondità. Ora è vero che la profondità, ad esempio di un pozzo, sconfina nell’oscurità, ma il filosofo non dovrebbe invece essere proprio colui che aiuta se stesso e gli altri a vederci chiaro? Ma allora perché alcuni filosofi parlano oscuro? Le risposte possono essere molteplici. Tra queste potrebbero esserci:
L’oscurità protegge sufficientemente dagli attacchi dei detrattori e consente una migliore difesa.
L’oscurità è tale solo per i non addetti ai lavori mentre per gli altri filosofi lo è un po’ meno.
L’oscurità dipende dal fatto che non si è lavorato abbastanza sulla comunicabilità delle proprie riflessioni, rivelando in tal modo, mi sembra, scarsa considerazione del diritto alla comprensione dei destinatari delle medesime.
L’argomento è comunque molto stimolante. Magari ne parleremo più in là..
ciao..
@rozmilla;
Grazie per la calorosa accoglienza, ricambio affettuosamente.
Belle le due citazioni. Se ho colto bene le intenzioni di Kafka, l’ultima frase si potrebbe riformulare così: La verità è l’idea di cui ha bisogno la vita per continuare.
Scusami se non mi soffermo ulteriormente sulle tue riflessioni, ma l’ora è decisamente tarda (almeno per me), e dopo una giornata di lavoro sulle spalle il rischio di dire fesserie è veramente alto..
Non mancheranno certamente altre occasioni per approfondire..
Un abbraccio
@Francesco: comprendere le differenze (che è fondamentale per non farsi la guerra) è cosa diversa dal superarle. A meno che tu non intenda superarle solo comprendendole, ed allora è un po’ come l’Aufhebung hegeliano, che supera e conserva nello stesso tempo. Però io non intendo annettermi nulla, ma solo contemplare l’altro da me, sapendo che è solo altro-da-me, dunque non altro in assoluto. L’assoluto (ammesso che esista) è solo ciò che riconnette tutte le alterità – che hanno eguale (ed assoluto) diritto ad esistere.
Che – almeno in linea teorica – dovrebbe contemplare anche il caso-limite, assurdo ed intollerabile: il diritto ad esistere di Hitler; che però, da un altro punto di vista, poiché quel caso non ammette l’esistenza di tutte le alterità, finisce per autoannullarsi: secondo la prospettiva che ammette il conflitto (il confronto, la discordia della molteplicità) e non la guerra, Hitler è la sua stessa autocontraddizione e negazione. Hitler non può esistere.
Ma siccome – storicamente – è esistito, come la mettiamo?
Comprendere le differenze è cosa certamente diversa dal superarle, ma è il primo passo. Infatti non bisogna intendere il comprendere come una situazione in cui, dopo che si è compreso, non ci siano altri passi da compiere. Non è una situazione congelata lì. Statica, definitiva. Alla comprensione deve seguire qualche altra cosa, forse, come dicevo, una danza.
Il superare le differenze consiste secondo me in una trasformazione, che è abbandono delle proprie rigide posizioni, o, il che è lo stesso, discesa dalle scale della torre d’avorio in cui anni e anni di costruzione teoretica ci hanno rinchiuso. Se lo desideriamo, ovviamente, non siamo mica obbligati. A mio parere l’incontro è più importante della fede nelle proprie opinioni. Cosa vuoi che sia il credere fermamente nelle proprie idee, davanti alla possibilità di incontrare veramente il nostro prossimo?
Sull’annettere o meno qualcosa.. beh.. certo.. anche qui non è obbligatorio, anche se qualche cosa, a volte, è sensato annetterla, se ne riconosciamo la validità. Però mi pare che fermarsi alla contemplazione, sulla soglia dell’osservazione (cosa per altro bella), ci impedisca di entrare realmente in contatto con l’altro. Apposta parlavo di danza, che non è esattamente contemplazione, ma coinvolgimento. Comunque sono scelte personali, per carità. Ognuno deve optare per quella che ritiene per sé migliore.
Sull’assoluto non capisco. Ho parlato di assoluto? Se l’ho fatto indicami dove.
In relazione al diritto all’esistenza di tutte le alterità sono d’accordo con te. Come sono d’accordo sul fatto che l’eventuale alterità che non riconosca il diritto all’esistenza di tutte le alterità non può che autoannullarsi. Ma questo è il piano logico/ideale, che non bisogna confondere con il piano reale, dove per altro possiamo agire e trasportare, se lo vogliamo, il principio del rispetto delle alterità attraverso la nostra condotta. Senza però aspettarsi necessariamente una risposta positiva da parte del mondo. Perchè il mondo, lo sappiamo, se ne sbatte frequentemente sia di noi, che della nostra condotta, che dei nostri principi. È fatto così, perché gli piace fare un pò come gli pare..
Buona serata,
Francesco
@Francesco: c’è un solo problema, che tale incontro con l’altro deve essere concreto, non per iscritto, non tramite parole scambiate di sbieco e da lontano.
Ma poi, una volta avvenuto questo incontro, segue anche un secondo problema: cos’ho io da dare o da dire a questo altro?
Sullo sfondo, però, mi vien da dire che occorra ancor prima definire cosa siano questo io e questo altro che si incontrano: “io”, ad esempio, assomiglia di più ad un fiume eracliteo che ad un essere parmenideo – e temo che ciò valga anche per “altro”.
ciò non toglie che l’incontro tra questi “io” e questi” altro” continui ad avvenire indipendentemente dalle teorizzazioni e rigidità – ma è prima di tutto sul piano della sympàtheia, dell’emotività e dei sentimenti che ciò avviene, e dunque senza che la ragione ci entri poi tanto…
Beh, ma se è per questo ho conosciuto un tizio che diceva sempre che in fondo in fondo “l’importante nella vita è limonare duro” … e quando lo diceva a quel punto nessuno riusciva a metterlo in dubbio.
Per fortuna (ma a volte anche per sfortuna) a questo mondo c’è un po’ di tutto …
@md:
È ovvio che le mie disquisizioni sull’incontro con l’altro si riferivano agli incontri reali, non a quelli virtuali (per quanto sarebbe interessante cercare di stabilire che quota di realtà vi sia, perché secondo me ce n’è, negli incontri cosiddetti virtuali). E per di più ne ho parlato, perché di certe danze ne ho fatto esperienza, come co-attore, diciamo così. Poi scusa, come sarebbe a dire, che non sai cosa dire e non sai cosa dare all’altro (parlo sempre di altri reali, ovviamente, non so tu. Anche se pure qui, gli scambi virtuali non solo dicono ma è ovvio che danno pure. Perché altrimenti che senso avrebbe il tuo blog se non riuscisse a dare nulla? Se tu continui a mantenerlo in vita e se noi continuiamo a frequentarlo è evidente che il blog qualcosa dà sia a te che a noi). La sola presenza di un essere umano già da sola dà qualcosa (nel bene e nel male), e così vale per quello che un essere umano dice (sempre nel bene e nel male).
Poi tu dici che sullo sfondo ti viene da dire che occorre prima definire cosa siano questo io e questo altro che si incontrano. Ebbene, per come la vedo io, l’io e l’altro che si incontrano, nel momento dell’incontro, smettono di essere l’io e l’altro precedenti all’incontro, per divenire qualcosa d’altro che prima non c’era, o meglio, che c’era solo in potenza. Potremmo definire questo nuovo io, l’essere per l’altro (ovviamente, in modo simmetrico, anche l’altro che incontra l’io, si trasforma in un io per l’altro).
.
Il fiume eracliteo mi pare un’ottima metafora per l’io, come per l’altro, in quando fa pensare al flusso che si muove all’interno di una persona, e che continua a muoversi anche quando avviene l’incontro con l’altro, passando però, in questo secondo caso, dal dentro al fuori. Come dire.. energia in potenza che assume varie forma a seconda della sua collocazione e del suo utilizzo. Parmenide lo lascerei da parte, perché mi pare un po’ lontano dalla vita, che non è immobilismo, né contemplazione degli Enti, ma attività (anche se la contemplazione, almeno a tratti, fa parte della vita).
È ovvio che gli incontri tra gli “io” e gli “altri” avvengono anche indipendentemente dalle teorizzazioni e dalle rigidità, ma di quali incontri si tratta? Qual è la qualità di questi incontri? Sono persone che interagiscono o semplicemente statue poste una di fronte all’altra? Cioè persone rigide, incapaci di comunicare veramente, o persone vive che sanno entrare in relazione?
La sympàtheia è la base. Senza sympàtheia non si da incontro. Si da solo frontale giustapposizione. Ma poi dalla sympàtheia iniziale, perché l’incontro si sviluppi, ci vuole, credo, anche la parola, e quindi la ragione.
Aspetta.. aspetta.. mi è venuta in mente una splendida definizione di simpatia di Merleau Ponty:
“La simpatia agisce allo stato libero nelle profondità del mondo”
(facendo una rapida ricerca su internet per verificare l’esattezza della frase, ho trovato che la medesima compare anche nel libro di Foucault “Le parole e le cose”).
Ciao e buona serata,
Francesco
(Avrei voluto stilare un commento più breve, ma proprio non ci sono riuscito..)
@rozmilla:
si, anch’io ho un amico che dice che ogni lasciata è persa..
ciao..
Siamo agli sgoccioli … così stavo passando in rassegna se per caso m’era rimasta qualcosa da fare, prima che finisca il mondo. Devo ancora lavare le fodere del divano, ma tanto se il mondo finisce chisseneimporta. E vista l’ora, c’è poco da fare. Ma forse, ecco, ho lasciato qualcosa in sospeso da dire – boccaccia mia, statti zitta.
Ma sì, lo ammetto: avevo detto una bugia. Non conosco nessun tizio che abbia detto quella brutta frase – e anche se ho scritto tantissimi commenti, una frase così volgare, pur se virgolettata, non l’avevo mai scritta. Quella frase mi era arrivata all’improvviso dalla televisione accesa, da un programma comico che “non” stavo seguendo. Non so cosa mi era preso. Forse i precedenti commenti mi avevano irritato. O forse tutti quei conflitti che ci son stati nell’ultimo periodo, di seguito uno all’altro .. con i vari V & V … insomma è stata una sequela alla fin fine abbastanza seccante. Così, non ho saputo resistere alla tentazione di dire una cattiveria alla faccia della sympàtheia. Anche se, a volerla leggere bene, una qualche verità ce l’ha anche quella cattiveria – detto terra terra, e crudemente.
Ma non sto chiedendo scusa, né le sto porgendo, per dirlo in maniera fine. Che anzi, visto che il mondo forse finisce – e meno male, o anche, sarebbe meglio – mi vien quasi da rincarar la dose e dire chisseneff … boccaccia mia … accontentiamoci di chissenefrega (non vuoi mai che poi non finisca)
Che poi sappiamo tutti, si spera, che il mondo ricomincerà già domani, sempre sperando che sarà meglio di questo che sta per finire.
Per la cronaca, è risaputo che il mondo in un certo senso finisce ogni anno il 21 dicembre in coincidenza del solstizio d’inverno, nel nostro emisfero, quando il sole raggiunge il massimo valore di declinazione negativa, e ogni anno ricomincia subito dopo la risalita. Anzi, da una rapida ricerca in wikipedia, è noto che ricomincerà a risalire domani mattina alle ore 11:11.
Quindi, tenetevi pronti: si riparte.
Bene. Sono contenta. M’è giunta anche voce che Pannella ha appena bevuto un bicchiere d’acqua. Et alors, à la santé.
e ora possiamo morire …