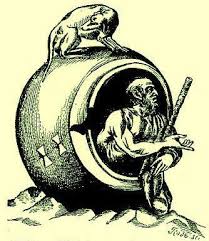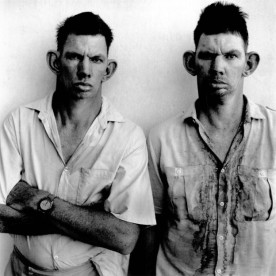[Traccia dell’incontro del Gruppo di discussione filosofica del 15 aprile 2024, ultimo incontro del percorso Animalia]
Nulla turba più i sapiens del silenzio,
o quello che a loro appare silenzio,
degli animali.
(F. Cimatti)
(Prologo)
Senzaparole è un albo illustrato dell’artista spagnolo Roger Olmos, pubblicato nel 2014, ormai dieci anni fa: si tratta di un piccolo capolavoro che rappresenta con alcune straordinarie illustrazioni il nostro rapporto criminale – non saprei come altro definirlo – con il mondo animale, ovvero con quei soggetti che sono senza parole, ma la cui infinita sofferenza ha cominciato a trovarle, a parlare, anzi a gridare. Senza parole non sono solo gli animali, ma innanzitutto noi umani, che distogliamo lo sguardo, che per vivere in una società fondata sul sangue e sulla violenza, dobbiamo innanzitutto rimuovere, tenere nascosta, non nominare e rendere invisibile proprio l’enorme gabbia che tiene imprigionata una moltitudine di viventi sfruttati. Ecco, partiamo proprio da qui, da questa rimozione, che è ancor più grave se viene imputata ai pensatori, ai filosofi, a coloro che invece le parole dovrebbero saperle trovare.
Partiamo dallo stupore di Peter Singer, uno dei grandi maestri dell’animalismo e dell’antispecismo, di fronte a questo mutismo.
Continua a leggere “Animalia VI – Liberazione umano-animale e koinè”