
(traccia dell’incontro del Gruppo di discussione filosofica tenutosi l’11 dicembre 2023)
[Sommario: Lògos e animali – Antropologi filosofi: Gehlen e Plessner. Carenza e posizionalità eccentrica – L’animale che dunque sono: Derrida – Il cogito cartesiano e il corpo-macchina – L’io kantiano e la ragion pratica criminale – Levinas e Lacan, en passant – Heidegger: umanismo biologico, troppo biologico – Mondo/ambiente – La solitudine umana – Postilla sul nome]
Ciò che caratterizza fin dall’antichità la riflessione filosofica sulla questione del rapporto umano-animale, è il paradigma della mancanza – che è poi l’elemento essenziale del punto di vista antropocentrico: l’umano che osserva il non umano lo trova mancante di ciò che caratterizza la propria umanità, innanzitutto del linguaggio e del pensiero.
La discussione sul lògos, facoltà di cui l’animale sarebbe o meno mancante, data fin dal IV secolo a.C., originato dalle scuole filosofiche più antiche (in particolare il Liceo di Aristotele) e portato avanti soprattutto dallo stoicismo. Le questioni più rilevanti sono due: innanzitutto se nel rapporto umano-animale si possa parlare di una continuità o non invece di una frattura radicale (con le categorie di quantità o di qualità a caratterizzare il passaggio: la differenza sarebbe solo questione di gradi nel primo caso, di essenza nel secondo); data poi la natura duplice del lògos (un lògos interiore identificato col pensiero ed uno esteriore, identificato con la sua espressione linguistica), il problema riguarda l’attribuzione o meno di queste facoltà all’animale, tenuto conto che molte specie sono dotate di codici comunicativi, capacità vocali, sonore, ecc. La cosa interessante è che questo dibattito originario istituisce i calchi e i luoghi comuni tipici di tutta la riflessione seguente, potremmo dire fino ad oggi.
Continua a leggere “Animalia II (con una postilla sul nome)”
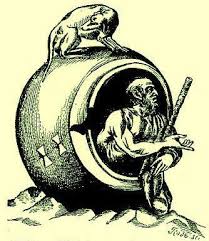

 Nel seminario L’animale che dunque sono, Jacques Derrida ci fa notare come l’incipit dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant sia di una violenza inaudita:
Nel seminario L’animale che dunque sono, Jacques Derrida ci fa notare come l’incipit dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant sia di una violenza inaudita:




